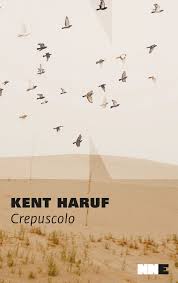 Crepuscolo, terzo volume della straordinaria Trilogia della Pianura di Kent Haruf – portata in Italia dalla felicissima intuizione di Nn, edizioni neonate ma già con un catalogo di tutto interesse – ci riporta a Holt in Colorado, cittadina assente dalle mappe fisiche ma assolutamente presente nella mappa emozionale del sempre maggior numero di lettori dello scrittore americano scomparso nel 2014.
Crepuscolo, terzo volume della straordinaria Trilogia della Pianura di Kent Haruf – portata in Italia dalla felicissima intuizione di Nn, edizioni neonate ma già con un catalogo di tutto interesse – ci riporta a Holt in Colorado, cittadina assente dalle mappe fisiche ma assolutamente presente nella mappa emozionale del sempre maggior numero di lettori dello scrittore americano scomparso nel 2014.
E’ in questo luogo dell’immaginario, in condizione di sospensione perfetta, che si svolgono le storie piccole e universali di personaggi amati come pochi altri in letteratura e che spesso ritornano di volume in volume (Canto della Pianura, Benedizione e Crepuscolo, appunto), allacciandosi l’una all’altra in un abbraccio che scalda e offre difesa e redenzione.
Ritroviamo in Crepuscolo Harold e Raymond McPheron, i due anziani allevatori che avevano accolto con sé la piccola Victoria Roubideaux, bambina in attesa di una bambina, cacciata di casa dalla madre alla scoperta di una gravidanza inattesa e inopportuna.
Le avevano aperto la porta sulle loro solitudini, i fratelli McPheron, accogliendola in casa come fosse, semplicemente, la cosa giusta. Nella sorta di equilibrio familiare inatteso che verrà a crearsi, come un piccolo miracolo, sarà lei, la piccola adolescente di origine pellerossa, dai capelli lucidi e neri che le ricadono sul volto, ricoprendone metà (un possibile richiamo ai Dormienti di Whitman?) a schiudere i due anziani alla tenerezza, forse tema portante su cui Haruf, già premio Whiting Foundation Award, costruisce tutta la Trilogia.
Crepuscolo si apre proprio con un’immagine della ragazza ormai diciannovenne intenta a dare il porridge alla figlia in un ultimo gesto domestico che presagisce un distacco, il momento critico: è il momento di lasciare casa McPheron e di andare all’Università.
Funziona così, le cose della vita vanno avanti: ricade nel previsto il rompersi di quell’inusuale equilibrio dove lei, i due anziani e la bambina erano riusciti ad accomodarsi, quel nucleo di dolcezza struggente di piccole cure, del parlarsi a gesti carezzevoli, del non detto.
Ma non tutto tornerà come prima: perché ha lasciato un segno, Victoria, una presenza di grazia e calore a contrasto con il gelo dei diciotto gradi sotto lo zero, della polvere e del vento (che assume tratti quasi di personaggio, levandosi forte in momenti decisivi a sferzare la pianura e gli animi di chi la abita).
E nella prosa luminosa e incantevole di Haruf, che rende questo romanzo un vero capolavoro della contemporaneità, saranno tutti fuorché uno gli abitanti di Holt a essere toccati dalla grazia, che questa si chiami Victoria Roubideaux o altro.
 C’è in Crepuscolo una presenza salvifica che lo attraversa, e tocca famiglie in disfacimento e i cattivi giri di vento: prende anche il nome di Dj, un undicenne che si prende cura del nonno. Di nuovo i piani sovvertiti, una saggezza che inaspettatamente non viene dall’età anziana ma da infanzia e adolescenza, e offre riparo. A Dj consegna un ruolo straordinario, Haruf: quello di un essere piccolo cresciuto a etica del lavoro, capace di sobbarcarsi ogni mansione adulta senza un lamento, senza una domanda. Spezza il cuore la sua semplicità nell’abnegazione, la prontezza nell’aiuto. Merita una carezza, DJ, cresciuto in una casetta buia accanto a un filare di gelsi, merita parole buone a lenire la sua solitudine. Le troverà forse nella figlia di una vicina, una bambina vittima incolpevole della deriva alcolica della madre abbandonata dal marito: se questa riuscirà a superare una resistenza alla parola che pare caratteristica di Holt tutta.
C’è in Crepuscolo una presenza salvifica che lo attraversa, e tocca famiglie in disfacimento e i cattivi giri di vento: prende anche il nome di Dj, un undicenne che si prende cura del nonno. Di nuovo i piani sovvertiti, una saggezza che inaspettatamente non viene dall’età anziana ma da infanzia e adolescenza, e offre riparo. A Dj consegna un ruolo straordinario, Haruf: quello di un essere piccolo cresciuto a etica del lavoro, capace di sobbarcarsi ogni mansione adulta senza un lamento, senza una domanda. Spezza il cuore la sua semplicità nell’abnegazione, la prontezza nell’aiuto. Merita una carezza, DJ, cresciuto in una casetta buia accanto a un filare di gelsi, merita parole buone a lenire la sua solitudine. Le troverà forse nella figlia di una vicina, una bambina vittima incolpevole della deriva alcolica della madre abbandonata dal marito: se questa riuscirà a superare una resistenza alla parola che pare caratteristica di Holt tutta.
E di abbandoni e di solitudini è anche un’altra storia, quella di una coppia che vive in una roulotte, immagine di un’America altra, che esiste, e si situa fuori dall’iconografia scontata. Nelle loro vite in esattamente al margine, pesano assenze: quella della prima figlia tolta loro dai servizi sociali.
Ma pesano anche le presenze: quella di uno zio, Hoyt, abominevole e violento che infierisce sui bambini e su chiunque gli capiti intorno con sadismo ripugnante. E’ l’unico personaggio non toccato dalla grazia di Holt e di Haruf e rimarrà indegno della nostra pietà.
Ritorna anche Rose Tyler, l’assistente sociale dolce e solida a portare un fondamentale giro nella trama, con i suoi gesti misurati e salvifici più di una preghiera, e con sguardi ed attenzioni di cui sarà fatto oggetto stavolta un personaggio in particolare: ma non è bene qui anticipare troppo.
Tutti personaggi amati come pochi in letteratura e che spiegano – in parte – l’immensa popolarità di Kent Haruf. Protagonisti di storie piccole, in un microcosmo inventato e universale (sul modello probabilmente di Faulkner, a cui Haruf dichiarava di dovere tanto, che aveva creato un’intera contea nella saga di Yoknapatawpha) fatto di cucine vissute, capanni degli attrezzi, tettoie metalliche. Dove ci si incontra o si decide di lasciar spazio, pur restando presenti, o ancora semplicemente ci si sfiora.
E’ materia delicata, questa, di sentimenti puri, e di silenzi, tanti.
 Di inadeguatezza, di limite nella parola trattenuta, di assenza di sentimentalismo di superficie: la difficoltà sta nel raccontare ciò che non si vede. Andava dunque forgiata una nuova lingua a modellarsi su questo contenuto, ed è anche qui che Haruf eccelle. “Voglio pensare di aver scritto quanto più vicino all’osso che potevo”, ha dichiarato.
Di inadeguatezza, di limite nella parola trattenuta, di assenza di sentimentalismo di superficie: la difficoltà sta nel raccontare ciò che non si vede. Andava dunque forgiata una nuova lingua a modellarsi su questo contenuto, ed è anche qui che Haruf eccelle. “Voglio pensare di aver scritto quanto più vicino all’osso che potevo”, ha dichiarato.
Ci è riuscito, perfettamente. Scarnificata, la sua è scrittura piana, potente, incantatoria.
Vi si colgono (solo sullo sfondo, non copiati, come substrato) i suoi autori preferiti – Faulkner, Hemingway, Cechov- , e poi echi di McCarthy, ma soprattutto dobbiamo riconoscere in Haruf un moderno e unico respiro epico straordinario, ampio, potente. Che ritroviamo intatto – altra nostra fortuna, dopo quella di avere scoperto questo autore – nella magnifica traduzione ad opera di Fabio Cremonesi.
