 […]dal momento in cui noi accettiamo la teoria dell’evoluzione, tutti i nostri concetti della vita organica corrispondono solo approssimativamente alla realtà. Altrimenti non ci sarebbe alcun cambiamento, il giorno in cui concetto e realtà coincidessero assolutamente nel mondo organico, non ci sarebbe più alcuno sviluppo […] e come possiamo passare da un rettile oviparo al mammifero che genera un essere vivente, senza che facciamo entrare in conflitto con la realtà uno o entrambi i concetti? […] Nel 1843 ho visto le uova dell’ornitorinco a Manchester, e con grande ottusità ho ritenuto una sciocchezza che un mammifero potesse deporre uova, ed oggi ciò è dimostrato! Lei non faccia dunque al concetto di valore la stessa cosa per la quale io ho dovuto poi chiedere scusa all’ornitorinco.
[…]dal momento in cui noi accettiamo la teoria dell’evoluzione, tutti i nostri concetti della vita organica corrispondono solo approssimativamente alla realtà. Altrimenti non ci sarebbe alcun cambiamento, il giorno in cui concetto e realtà coincidessero assolutamente nel mondo organico, non ci sarebbe più alcuno sviluppo […] e come possiamo passare da un rettile oviparo al mammifero che genera un essere vivente, senza che facciamo entrare in conflitto con la realtà uno o entrambi i concetti? […] Nel 1843 ho visto le uova dell’ornitorinco a Manchester, e con grande ottusità ho ritenuto una sciocchezza che un mammifero potesse deporre uova, ed oggi ciò è dimostrato! Lei non faccia dunque al concetto di valore la stessa cosa per la quale io ho dovuto poi chiedere scusa all’ornitorinco.
Friedrich Engels a Conrad Schmidt, dall’Isola di Wight, 12 marzo 1895
Non esprimetevi mai più chiaramente di come pensate.
Niels Bohr
Loro non sono andati al concerto.
Karlheinz Stockhausen sul 09/11
Caro Gian Paolo, grazie dell’invito alla festa per i vent’anni di Satisfiction, casca a fagiolo col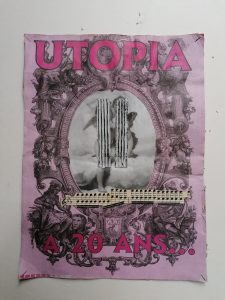 successo del ventennio di cui mi sto occupando per un progetto sull’11 settembre, di cui ti impagino una parte senza troppe coordinate, eccetto, approssimativamente, quelle in cui si trova la mia voce narrante, 11°09’01″N 17°06’13.12″W.
successo del ventennio di cui mi sto occupando per un progetto sull’11 settembre, di cui ti impagino una parte senza troppe coordinate, eccetto, approssimativamente, quelle in cui si trova la mia voce narrante, 11°09’01″N 17°06’13.12″W.
Chiamatemi Bill Sick, come tutti, e scusate se vi do dell’io, ma è l’unico modo in cui posso non pensarmi addosso in polemica con Aristotele, prima di ribadire: per natura, gli uomini, più che al sapere, tendono al morire.
Specie se aspettano la terza guerra mondiale a bordo dell’Ariete che imbarca acqua sul fondo del Pacifico settentrionale, poco oltre Honolulu, come me che registro questo oceanico funeral party di Schrödinger prima che la pressione dell’acqua sfondi le paratie del sommergibile senza il piacere e il privilegio di averti vicino, mia Lugano.
Sarà che è tutta la vita che galoppo via da Samarcanda, ma anche se è stato bello dire che scamparla era più improbabile che impossibile, ora la difficile questione del tempo impone un salto dialettico all’intera vicenda: raccontare tutto a tutti per farlo avverare faccia di me l’ammutinato ideale, più che il testimone, di una rotta sconosciuta che si porta appresso una marmitta piena di cose visibili e invisibili, specie le più indigeribili: bombe a mano, pietre focaie, auroni pronti a scartare di lato e cadere, rotaie.
 In effetti era anche ora che questa caricatura d’Ismaele prendesse l’intero viaggio come un frattale di autoconsapevolezza narrativa e smettesse di cercare il senso di cui la vita sembra irrimediabilmente priva, che finalmente questo Quello che balla degli 883 accettasse la grande burla universale che c’era e non c’era una volta in sé.
In effetti era anche ora che questa caricatura d’Ismaele prendesse l’intero viaggio come un frattale di autoconsapevolezza narrativa e smettesse di cercare il senso di cui la vita sembra irrimediabilmente priva, che finalmente questo Quello che balla degli 883 accettasse la grande burla universale che c’era e non c’era una volta in sé.
Nel compiersi del mio destino, ho il cuore colmo di gratitudine come un bambino per questo spensierato tipo di filosofia da disperato che mi infuria dentro come un ossesso, mentre bivacco sull’abisso, ricordando all’estraneo di me stesso, che di tutti gli uomini, miserabili o gaudenti, sono proprio i marinai a pasticciare tanto coi loro estremi sentimenti.
Questo messaggio vocale in bottiglia sia il mio testamento, la mia vaga idea di amore, furto, famiglia, l’atto di fede nella singolarità del duo che sembra un trio che a volte sono solo io che mi imbriglia.
È dal 2001 che continuiamo a cadere, a precipitare dal tragico all’osceno della nostra vita indiretta, come mutanti all’apice di un masochismo pieno di affanni fruito in sacrificio e remissione dei nostri peccati nella forsennata accelerazione temporale degli ultimi decenni.
In bilico tra iconoclastia e iconofilia, ipersensibili e brutali, irrequieti e vanitosi, pornografici e creativi, ho visto i migliori della mia generazione andare in frantumi nelle collisioni storiche di un modo di produzione sublimato alla sua fase supremamente disfunzionale, maturate dalle contraddizioni accumulate nel cosiddetto “periodo di pace” – dalla fine del secondo conflitto mondiale alla pandemia del capitale -, imbevute di storytelling dai mutevoli effetti di realtà, conseguenza e premessa di ogni prossima ventura diventità.
Sarebbe stato difficile, per quelli dopo, dire chi aveva fatto, pensato, o vissuto prima cosa (fosse una cosa, un’altra cosa, o qualsiasi cosa) alimentasse in noi abissi creativi tenuti cannibalescamente insieme dall’alienazione che animava la farsa cartoonesca della tragica contesa dei mercati, col suo bastimento carico di morti, feriti, sfollati.
cosa, un’altra cosa, o qualsiasi cosa) alimentasse in noi abissi creativi tenuti cannibalescamente insieme dall’alienazione che animava la farsa cartoonesca della tragica contesa dei mercati, col suo bastimento carico di morti, feriti, sfollati.
Tra istanze geologiche, biologiche, economiche, politiche, sociali, e abitudini mediatiche ibridate tra documentari e telenovele tribali, siamo cresciuti nell’interno giorno di un reality di esodi, sparatorie, demolizioni incontrollate, e uomini che cadono fin da quella coda d’estate, che ci saldò, così spettacolarmente, nella sutura compressa fra due grandi crolli interconnessi intimamente a noi stessi. La febbre ci ha fatto crescere di un altro centimetro almeno a cavalcioni del Muro prima di interpretare il milite ignoto che si getta dalle torri in volo, l’urlo muto, l’assolo, con cui il cuore delle velleità occidentali andava così scenograficamente in frantumi, epitaffio al decennio più lungo del secolo breve, insieme al nostro pessimo karma, per cui il contatto con la terra non sarà mai lieve: come se d’inverno, un vagabondo, si mettesse in viaggio al termine della notte buia e piena di terrori del dharma.
All’inseguimento di un sentimento del tempo senza più crismi per creare nuove rovine, di memorabili flash nella sovrabbondanza di server dove tutto per sempre potenzialmente ci appartiene, condannati all’atto psicomagico di un oblio confusionario di specie, presi d’insieme indistinguibili da chiunque voi siate, ventimila leghe in superficie.

Per lo stesso principio con cui l’acqua va in ebollizione, la nostra spinta alla condivisione, il legame con l’inferno e il paradiso che sono per noi gli altri in quanto estremo paragone, è una forma di autofiction before crisis credere di essere esseri umani che ignorano come finirà la storia di una specie che fa puntualmente crollare gli idoli eretti ieri per idolatrarsi domani.
Quanto eravamo distratti, mentre passeggiavamo al cimitero della Castagna, fra tombe dimenticate, con la rugiada che ci bagna a tenerci stretti all’idea fossile di ossa tremanti, accatastate, come un formicolio che dalla terra ci arrivava fino alle labbra ardenti, quand’ecco, che finalmente ci è spuntato il becco! Che la mutazione narrativa diventava l’inevitabile conseguenza e la subliminale premessa che ci avrebbe portato a sentire, volenti o nolenti, che ci fosse qualcosa di alieno in tutto ciò che è umano, fossimo maschi, femmine, o cantanti. Che doveva esserci qualcosa di vero in quello che fingevamo così completamente di credere fosse il dolore che davvero sentivamo, o nel modo in cui ce lo raccontiamo mentre lo diventiamo. Che per quanto sperduti, soltanto uniti assottigliamo lo spread tra la realtà e il concetto di realtà che inseguiamo, per raggiungere il fulcro del conflitto come tanti Nessuno, e centrare il punto di rottura di quest’asintotico rimpiattino tra fatti e interpretazioni di fatti, al di noi dentro e fuori, di cui siamo contemporaneamente autori, protagonisti e spettatori.
Così ci siam detti: se è questo essere o non essere uomini seri, se siamo costretti, davvero, ad accettarne il mistero come l’arrivo per posta di un qualunque Abraxas di Santana, o la critica della critica di Superman alla razza umana, se presi singolarmente siamo solo tanti brutti figli di puttana, basta che ci relativizziamo fino a svanire nella polvere di stelle che eravamo e ritorneremo, e anche con tutta la nostra stanziale dromomania, guardando al bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, quel che non ci mancherà, di quel che non abbiamo, è la monotonia.
accettarne il mistero come l’arrivo per posta di un qualunque Abraxas di Santana, o la critica della critica di Superman alla razza umana, se presi singolarmente siamo solo tanti brutti figli di puttana, basta che ci relativizziamo fino a svanire nella polvere di stelle che eravamo e ritorneremo, e anche con tutta la nostra stanziale dromomania, guardando al bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, quel che non ci mancherà, di quel che non abbiamo, è la monotonia.
Dacché c’è data licenza di ricordare, ci succedono guerra, disboscamento, affamamento, carestia, monogamia, Chernobyl, il Muro di Berlino, L’Iraq, i Balcani, l’11 settembre, l’Afghanistan, di nuovo l’Iraq, la paranoia dei musulmani contro i cristiani, la Libia, la Siria, la crisi globale, Fukushima, i cimiteri del mare, la prima pandemia secolare.
Tutta la nostra vita cosciente è intrappolata nelle spirali di questo serpente che si morde la coda nell’eterno ritorno del nulla che ci crea e del nulla che ci distrugge del presente, un’evoluzione pop esperienziale, un patto postpunk narrativo emozionale tenuto insieme con gli stessi click con cui si chiudono le scatole ben fatte – piene di ferite, fenditure, lotte – nella memoria deframmentante che ci lega, strana sorella, alla pubblica intimità di un istante: dov’eri tu quando crollavano le torri, dove finiscono gli avventi del nostro orizzonte, quando calienta el sol, anche se strisci e non inciampi, dove corri?
 Siamo come il calabrone che è troppo pesante per volare ma vola lo stesso perché nessuno lo ha avvisato che non lo può fare, o i pavoni che fanno la ruota, o i fenicotteri in una televendita di Mastrota, che diventano rosa per sventura – pensare che sarebbero bianchi come fantasmi, se non fossero così dipendenti dai gamberetti, quegli ingordi bulimici che fenicotterano senza paura.
Siamo come il calabrone che è troppo pesante per volare ma vola lo stesso perché nessuno lo ha avvisato che non lo può fare, o i pavoni che fanno la ruota, o i fenicotteri in una televendita di Mastrota, che diventano rosa per sventura – pensare che sarebbero bianchi come fantasmi, se non fossero così dipendenti dai gamberetti, quegli ingordi bulimici che fenicotterano senza paura.
Mettiamo in scena rapsodie, stravaganze dell’evoluzione, come l’arte, la letteratura, la musica, tracciamo un’anatomia dell’irrequietezza composta da elaborati rituali d’accoppiamento, come uccelli a malapena in grado di volare sopravento, schiacciati a terra da una forza di gravità che tecnicamente neanche esiste, ma agisce, come la mafia, non solo d’estate. Cambia il rapporto della realtà tra di noi, sepolcri di cowboy che ravaniamo nel fango, mentre cadiamo sul sole, consolandoci con l’idea che la nostra effimera bellezza ci impedisca di sfiorire o scordarci come le viole.
Sconfitti in partenza nel dare ordine al caos, con tutta la nostra incandescenza, la più grande opera d’arte del cosmo rimane la dittatura dell’incerto, l’invito a non andare al concerto, a diventare per noi stessi fantasmata, fermo immagine, buffering, ologramma, cartolina dalla mutazione, anarchia, libertà, partecipazione al nostro programma.
Personaggi del videogioco di una nazione al di là dello spazio, una generazione fuori tempo massimo, una degenerazione di militi ignoti presa d’assalto dallo sgomento di uomini che cadono mentre gridano:
Signore e signori, venghino a vedere!
Tra l’aquila americana e il dragone cinese, l’orso russo, le tigri asiatiche, e il leone inglese, la solitudine dell’ornitorinco europeo nella rete dello zoo multipolare!
Mai stato fedele, non più analogico, non ancora digitale, sa soltanto quello che non sa di essere – frattale da vecchi film di Woody Allen o dalla vita comune – e che l’amore è tutta questione di coordinazione, come ogni tragica farsa storica, o un’indigestione di patatine alla paprica.
Indegni apocrifi di arti varie, per un senso di calamità, per tutto quel che è eccesso, o ci spaura,

comunque vada sarà un successo questo spettacolo delle macerie che sta diventando una storia vera. Sia che faremo la fine dei panda o dell’araba fenice, con un’overdose di ostalgie nella tana del coniglio di Alice, cavalcheremo fino alla fine questo strano siluro di fiumi di parole e faremo tanto rumore per nulla senza perderci in pinzillacchere e quisquilie, finché non daremo tutto il potere al Soviet delle Meraviglie.
Così sarà, se ci pare, la fine del sabato del villaggio globale, dove tutti si sta sospesi a fare i conti con l’insorgere di un principio policromo di indeterminazioni a ogni diretta del vivere a colori le nostre caleidoscopiche frammentazioni.
E se ancora per un attimo potremo averci accanto, forse non ci diremo niente, ma ci guarderemo soltanto, nell’illusione di comunione e liberazione che una musica leggera ci renda più sostenibile la pesantezza dell’essere sul far della sera, specchio riflesso delle nostre brame, senza più bisogno di parole per spiegare quello che ci è nascosto in fondo al cuore, e arrivare a domenica mattina, e fare entrare l’alba, senza nemmeno un’inquietudine al nostro fianco ad ancorarci al mondo prima.
Di una rivoluzione.
Di te.
Dell’avvenire della mutazione.

Perciò brindo alla Terza, ai nostri debiti, ai caduti, e ai miei cliché, mentre cerco qualche lei o qualche me nel pensiero abbacinante della violenza dell’universo, nel tutto in fuga che ci sovrasta, in quel niente che abbiamo lasciato e perso, nei Santi numi voglio scendere, basta! Fermate la giostra!, visto che quasi certamente niente esiste al di fuori di questa stanza, e che se il vuoto è pieno della tua assenza, mia Lugano, niente avrà nessunissima importanza.
Come il necessario inganno ch’è meglio lasciarci per non smettere mai d’incontrarci, o credere di essere esseri umani che si sognano androidi che sognano fenicotteri atomici e futuri apocalittici lontani mentre fabbricano con le loro stesse mani le catene alla quotidianità del male e alla banalità dell’insieme.
Per raccontarci più della somma delle nostre parti, tutt’altro che eroi, al limite ornitorinchi europei, liberi abbastanza a lungo da non sentirci cattivi nel prenderci un attimo per dire a dio di continuare a farsi i fatti suoi, e diventare la riprogrammazione casuale che causerà altri ipertesti di errori di una storia per cui non c’è nessuna chiave giusta, se non che la porta è sempre stata aperta, e basta tirare la maniglia e andare fuori.
