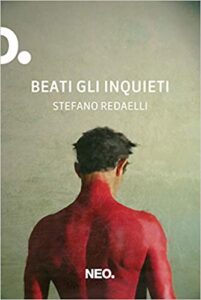 Beati gli inquieti è il nuovo romanzo di Stefano Redaelli, pubblicato nel 2021 da Neo edizioni nella collana Iena: Antonio, protagonista e voce narrante, decide di raccontare la follia calandosi nell’ambiente che ospita i pazienti della struttura psichiatrica “Casa delle farfalle”. Una settimana soltanto, è questo il patto, per scrivere il libro. La struttura del romanzo che stiamo leggendo non segue la tradizionale linea narrativa. La divisione temporale, gli esercizi e i test proposti a chi legge, scardinano il comune senso del lettore. Un realismo psicotico che fa del discorso delirante orizzonte di eventi creativi. Caos di ferite profonde e irrazionali, reali. Riferimenti che rasentano la compiutezza saggistica, seppure tutto galleggi in una bolla di rarefatta, solida, tenera stranezza. I corpi tradiscono verità e solitudini incomunicabili. Il finale è l’inizio di ogni possibile riflessione su chi siamo davvero. Su cosa sia reale in questa illusione chiamata vita. Il romanzo è candidato alla 75° edizione del Premio Strega 2021 e alla 59 edizione del Premio Campiello 2021.
Beati gli inquieti è il nuovo romanzo di Stefano Redaelli, pubblicato nel 2021 da Neo edizioni nella collana Iena: Antonio, protagonista e voce narrante, decide di raccontare la follia calandosi nell’ambiente che ospita i pazienti della struttura psichiatrica “Casa delle farfalle”. Una settimana soltanto, è questo il patto, per scrivere il libro. La struttura del romanzo che stiamo leggendo non segue la tradizionale linea narrativa. La divisione temporale, gli esercizi e i test proposti a chi legge, scardinano il comune senso del lettore. Un realismo psicotico che fa del discorso delirante orizzonte di eventi creativi. Caos di ferite profonde e irrazionali, reali. Riferimenti che rasentano la compiutezza saggistica, seppure tutto galleggi in una bolla di rarefatta, solida, tenera stranezza. I corpi tradiscono verità e solitudini incomunicabili. Il finale è l’inizio di ogni possibile riflessione su chi siamo davvero. Su cosa sia reale in questa illusione chiamata vita. Il romanzo è candidato alla 75° edizione del Premio Strega 2021 e alla 59 edizione del Premio Campiello 2021.
«Prima gli esercizi spirituali, poi il pellegrinaggio; mancava l’autoricovero a fini letterari.» Siamo all’inizio dell’avventura e il protagonista si presenta, si racconta con un tono quasi distaccato. Ci viene il dubbio che si tratti di un vero e proprio reportage e che insomma Antonio sia l’alter ego dell’autore. La spiritualità e la creatività sono al centro di questo percorso: il laboratorio di lettura condotto da Antonio ne è la prova. Che rapporto vedi tra creatività, spiritualità e follia? e come si colloca la tua scrittura rispetto a questi tre orizzonti di cui sei tu stesso appassionato?
Sono diverse, innanzitutto. Ma credo siano sorelle. Hanno in comune un salto dalla norma, un volo. La creatività è il di più della conoscenza; vediamo, sentiamo, immaginiamo ciò che ancora non esiste, conosciamo ciò che ancora non c’è, e lo facciamo esistere. La spiritualità ci fa abitare un mondo che non è solo materiale: include e trascende la norma materiale, ci rimanda a un Altrove, un Altro cui finalizzare il senso dell’esistenza. La follia è lo scarto dal senso stesso, dal buon senso in quanto razionalità, da una norma di salute, ordine, collocazione nella società. Come vedi, sono cose diverse, prossime. La scrittura da una parte ne indaga la parentela, dall’altra è uno strumento al loro servizio. La parola dà forma all’inesprimibile della follia, all’ineffabile della spiritualità, all’inesistente della creatività. O almeno ci prova, è protesa. In questo senso per me la scrittura è sacra.
dalla norma, un volo. La creatività è il di più della conoscenza; vediamo, sentiamo, immaginiamo ciò che ancora non esiste, conosciamo ciò che ancora non c’è, e lo facciamo esistere. La spiritualità ci fa abitare un mondo che non è solo materiale: include e trascende la norma materiale, ci rimanda a un Altrove, un Altro cui finalizzare il senso dell’esistenza. La follia è lo scarto dal senso stesso, dal buon senso in quanto razionalità, da una norma di salute, ordine, collocazione nella società. Come vedi, sono cose diverse, prossime. La scrittura da una parte ne indaga la parentela, dall’altra è uno strumento al loro servizio. La parola dà forma all’inesprimibile della follia, all’ineffabile della spiritualità, all’inesistente della creatività. O almeno ci prova, è protesa. In questo senso per me la scrittura è sacra.
«La parola deriva dal latino desertus, participio passato di deserere: abbandonare, lasciare in abbandono.» Il romanzo pullula di citazioni letterarie (Beati gli inquieti è un esplicito riferimento al Vangelo Secondo Matteo), scientifiche («Un semplice battito d’ali può scatenare una tempesta […]», mantra delle Teorie della Complessità, è quanto disse il matematico e meteorologo Lorenz), e poi Jung, Fromm, Bach, Il Piccolo Principe. Le comunità psichiatriche sono in effetti questi piccoli mondi. Il romanzo scivola in brevi capitoletti, scorre e con levità sa penetrare i territori delicatissimi, e a volte crudeli, del disagio mentale. Come hai lavorato per organizzare un materiale tanto variegato?
 Ho raccolto per anni (più di dieci) storie, discorsi, deliri, versi, lettere, epifanie strazianti e poetiche di pazienti psichiatrici. Ho ascoltato e trascritto. Per anni. Poi ho lasciato decantare tutto per altri anni, prima di riprendere, con un distacco dal vissuto, quelle pagine incandescenti e reinventarle, riscriverle, trasformarle in un romanzo, con una sua struttura narrativa, delle voci nette, riconoscibili, “comprensibili” anche nel delirio. È stato un lavoro lungo e difficile. Più mi allontanavo dalla realtà più riuscivo a maneggiare e plasmare la materia fattuale che anima il romanzo. Ho scelto una struttura apparentemente lineare e un linguaggio nitido per ospitare la “nonlinearità” e una luce a tratti oscura. Nonostante questo, persiste nella narrazione una forza centrifuga, divergente, che non ho voluto imprigionare, per non imprigionare la follia stessa a cui cerco di dare voce, libertà di espressione.
Ho raccolto per anni (più di dieci) storie, discorsi, deliri, versi, lettere, epifanie strazianti e poetiche di pazienti psichiatrici. Ho ascoltato e trascritto. Per anni. Poi ho lasciato decantare tutto per altri anni, prima di riprendere, con un distacco dal vissuto, quelle pagine incandescenti e reinventarle, riscriverle, trasformarle in un romanzo, con una sua struttura narrativa, delle voci nette, riconoscibili, “comprensibili” anche nel delirio. È stato un lavoro lungo e difficile. Più mi allontanavo dalla realtà più riuscivo a maneggiare e plasmare la materia fattuale che anima il romanzo. Ho scelto una struttura apparentemente lineare e un linguaggio nitido per ospitare la “nonlinearità” e una luce a tratti oscura. Nonostante questo, persiste nella narrazione una forza centrifuga, divergente, che non ho voluto imprigionare, per non imprigionare la follia stessa a cui cerco di dare voce, libertà di espressione.
«I gesti, fini a se stessi, staccati dal desiderio, dal senso, diventano assurdi» e la scrittura di Redaelli è animata da un continuo desiderio che affascina con il gioco dei punti di vista, una polifonia di sguardi che si contrappongono alla rigidità della malattia, una regola sempre trasgredita che si fa musica, fugge, fa del disagio un’arte. La tua scrittura da cosa è stata mossa, c’è un perché è nato questo libro?
Dietro questo romanzo c’è una bella storia di amicizia, ascolto, studio. Quattordici anni fa un’amica, che frequentava con la Comunità di Sant’Egidio una struttura psichiatrica, mi ha chiesto se volevo trasformare i loro diari in un romanzo, per poi partecipare a un concorso letterario, vincerlo e dargli il premio in denaro da utilizzare per la struttura. Una richiesta geniale: folle e fiduciosa. Ho raccolto l’invito, ma le ho detto che avrei avuto bisogno di sperimentare in prima persona quello che loro sperimentavano. Mi sono rivolto a una struttura psichiatrica e ho chiesto di poterla frequentare come “amico-scrittore”. Così è iniziata un’esperienza, che non è ancora finita: continuo a frequentare gli amici della struttura. Ho scoperto con loro il valore dell’ascolto. Lo scrittore non è uno che scrive, è uno che ascolta. La follia insegna, richiede un ascolto incondizionato: non capiamo il senso del discorso, non gestiamo le emozioni che ci investono, ma ci sforziamo di rimanere in ascolto, di accoglierle. Ho capito che la follia vuole questo: essere ascoltata, accettata, anche se fa paura. È un ascolto rischioso, ma illuminante.
«Quando ero piccola, giocavo a nascondino con i fiori»: si apre così il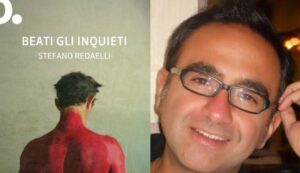 capitolo intitolato Marta. Ogni capitolo di Marta è scritto dal punto di vista di Marta. Antonio presta gli occhi agli ospiti della struttura fino a renderli parte essi stessi della narrazione. Simone, Carlo, Marta, Cecilia, Angelo, la Dottoressa: appaiono in scena, proprio, in quei capitoli organizzati come sceneggiature teatrali (Il Piccolo Principe della Casa delle Farfalle, a esempio). I personaggi hanno storie diverse, soggetti diversi tra loro nella comune condivisione degli spazi e del tempo: come sono nati?
capitolo intitolato Marta. Ogni capitolo di Marta è scritto dal punto di vista di Marta. Antonio presta gli occhi agli ospiti della struttura fino a renderli parte essi stessi della narrazione. Simone, Carlo, Marta, Cecilia, Angelo, la Dottoressa: appaiono in scena, proprio, in quei capitoli organizzati come sceneggiature teatrali (Il Piccolo Principe della Casa delle Farfalle, a esempio). I personaggi hanno storie diverse, soggetti diversi tra loro nella comune condivisione degli spazi e del tempo: come sono nati?
Alcuni personaggi sono ispirati da tratti (linguistici, caratteriali) dei pazienti che ho conosciuto. Ma non c’è mai corrispondenza. In un personaggio letterario convergono caratteristiche di persone reali e tratti inventati. Altri personaggi sono puramente frutto di invenzione. L’interazione feconda tra invenzione e realtà è stata costante. Una frase del libro è presa alla lettera da un paziente ed è così vera da sembrare inventata: “Si può costruire nel deserto”. È stato il buongiorno di Antonio, quando ho varcato per la prima volta il cancello della struttura.
«La mia vita non sta in un angolo \ la mia vita sta in tanti angoli» è una delle poesie di Cecilia, raccolte nel capitolo Tutte le poesie. In apertura i versi del poeta Mario Luzi. Tutto il romanzo condivide con la poesia uno sguardo che rende sperimentale l’approccio alla tua scrittura, per lo meno in questo lavoro. Ma che ruolo ha la poesia nella tua vita letteraria e in quella di studioso?
Mi occupo per lavoro prevalentemente di narrativa e questo mi consente di leggere la poesia senza la deformazione professionale dello studioso. Vorrei continuare a mantenere questo rapporto “puro” con la poesia, se ci riesco… Nel romanzo c’è una presenza costante della poesia, la scrittura è mossa da una tensione poetica, sia nella frammentazione e musicalità della prosa, sia nell’inseguimento lirico delle improvvise impennate deliranti delle voci. Credo che sarebbe stato impossibile costruire, raccontare questa storia senza la poesia. Qui la sorellanza con la follia è cruciale. O forse la poesia è un modo di sentire così radicato da non poterne prescindere quando scrivo.
«Questo libro è rivolto ai geni di ogni classe» siamo all’epilogo, la storia si è conclusa in modo del tutto imprevedibile, le certezze crollano, la logica vacilla e ciò che resta è la creatività del desiderio. E dell’amore. Gli ultimi esercizi che ci propone la voce narrante evoca quel grandioso esperimento poetico-letterario del 1965 di Yoko Ono dal titolo Grapefruit. Istruzioni per l’arte e per la vita. Il libro che abbiamo appena letto, Beati gli inquieti, è forse una favola, un’espressione alta dell’esercizio di stile, o forse uno specchio nel quale non tutti amiamo riflettere l’oscura profondità che ci abita. Che cosa è secondo te la follia? ammesso che esista davvero?
Non posso né voglio dare una definizione. Una definizione sarebbe una prigione, un manicomio. E la follia è in continua fuga da ogni manicomio, da ogni definizione che la voglia imprigionare. Certo, nel romanzo non mancano momenti in cui sembra che si stia dando una definizione della follia, ma un attimo dopo quella definizione non è più attuale. Alla fine un romanzo è questo: ciò che non può essere detto in alcun altro modo.
Gianluca Garrapa
