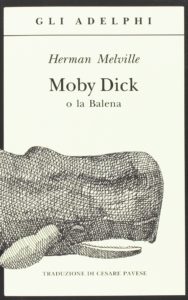 Chiamatemi Ismaele
Chiamatemi Ismaele
È l’incipit fulminante per antonomasia: due sole parole, un appello. Se voi, Lettori, così chiamerete il Narrante, entrando in una confidenza ineluttabile, si schiuderà ai vostri occhi una vicenda tragica e straordinaria di ossessione e resistenza, di coraggio e tenacia, di un tentativo superbo dell’Uomo di soggiogare Natura e Destino.
Con la dichiarazione del narratore dal nome biblico prende l’abbrivio un capolavoro della letteratura di tutti i tempi, più citato che letto nella sua interezza, Moby Dick di Herman Melville.
Un libro che ebbe inspiegabilmente un’accoglienza miope e fallimentare alla sua uscita nel 1851 quando fu bollato come indigeribile pastiche tra il saggio, l’epico, il romanzo marinaresco e di formazione, il pamphlet filosofico carico di riferimenti ad altre opere e a tratti perfino ironico, di un’ironia che non alleggerisce.
Vendette poco più di tremila copie, Moby Dick, e segnò il fallimento, quasi la fine della carriera del suo autore che non riuscì più a scrivere nulla di tale portata.
Ci vorranno più di settant’anni e un’opera di recupero di scrittori generosi – tra cui D. H. Lawrence -perché Moby Dick venga rivalutato come “epopea epica” e “opera enciclopedica”, aprendosi a un successo straordinario e consolidando Melville tra i dodici creatori del Canone americano indicato da Harold Bloom.
Ismaele è l’unico sopravvissuto – ma non è il protagonista centrale – della vicenda, e come l’Ancient Mariner di Coleridge racconta sulla spinta di un’urgenza: deve narrare ciò che è successo dopo che si è imbarcato sulla baleniera del capitano Achab e si è spinto ad affrontare le acque, gli abissi, i suoi per primi, e la balena bianca del mito, enorme mostro marino con cui Achab ha un conto aperto perché sfuggendogli lo ha menomato, tranciandogli una gamba. È la vicenda di questo capitano e quella di tutti i suoi marinai e ramponieri la storia che riporta Ismaele respinto dalle onde, novello Mosè riportato alla vita sulla bara coperta di magici segni di Queequeg, uno dei compagni nella missione, sorta di Buon Selvaggio.
Condannato al racconto, carico di dolore, allegoria egli stesso, Ismaele si fa voce delle battaglie di Achab fin dalla partenza obbligata dal porto, che è pietoso; [perché] nel porto v’è la sicurezza. La comodità, la lastra di pietra del focolare, la cena, le coperte calde, gli amici, tutto ciò che è benigno alla debolezza della nostra condizione umana. Ma il porto, la terra, costituiscono il pericolo più tremendo per quella nave; essa deve rifuggire ogni ospitalità, e per assecondare la sete di vendetta e di conoscenza deve riguadagnare tutta l’assenza di terra dell’infuriato mare.
È figura epica e gigantesca, Achab, dominata da un desiderio sovrumano, il delirio di onnipotenza nel voler possedere e travalicare – tramite la sua uccisione – quella sua ossessione, il capodoglio da annientare, simbolo di potenza e del Male, un Male qui di inatteso biancore assoluto.
La sua lotta disperata nel libro – contrariamente alle versioni  cinematografiche – la compirà quasi interamente dal chiuso della sua cabina: un luogo asfissiante, scabro e essenziale (Achab ha rinunciato a tutti gli agi, è celeberrima la scena in cui getta in mare da subito la pipa, suo solo conforto) e i pensieri si potenziano comprimendosi su un unico obiettivo che il lettore percepisce impossibile fin dalla prima giornata di caccia, il sopprimere l’indifferente animale dalla potenza delle profondità: tranquilla, fascinosamente tranquilla tu nuoti, oh, balena! Tu nuoti per tutti quelli che ti vedono per la prima volta, non importa quanti tu abbia in quello stesso modo giocati e distrutti prima. Tutto ciò, si percepisce, si ripeterà, e il gioco e la distruzione.
cinematografiche – la compirà quasi interamente dal chiuso della sua cabina: un luogo asfissiante, scabro e essenziale (Achab ha rinunciato a tutti gli agi, è celeberrima la scena in cui getta in mare da subito la pipa, suo solo conforto) e i pensieri si potenziano comprimendosi su un unico obiettivo che il lettore percepisce impossibile fin dalla prima giornata di caccia, il sopprimere l’indifferente animale dalla potenza delle profondità: tranquilla, fascinosamente tranquilla tu nuoti, oh, balena! Tu nuoti per tutti quelli che ti vedono per la prima volta, non importa quanti tu abbia in quello stesso modo giocati e distrutti prima. Tutto ciò, si percepisce, si ripeterà, e il gioco e la distruzione.
Moby Dick venne tradotto in Italia in diverse edizioni: la più nota rimane quella coraggiosa di Cesare Pavese per Frassinelli (1932), un lavoro che gli costò un corpo a corpo durato anni nella resa degli echi shakespeariane, miltoniani e di una lingua ricchissima che passa dal tecnicismo marinaresco stretto alla musicalità del poema in prosa. Nella sua o nelle altre edizioni svecchiate – di Massimo Bacigalupo o di Ottavio Fatica, per citarne solo un paio – rimane un caposaldo irrinunciabile, a tratti struggente, come nell’ultima orazione di Achab, pagina disperata e tragica, invettiva urlata prima di gettare il lancione nel fianco della balena, solo ora definitivamente voltando la schiena al sole.
Anna Vallerugo
