
Un pomeriggio freddo, al tavolino di un bar in Piazza San Babila a Milano, incontro Eugenio Viola (Napoli, 1975) prima del suo rientro a Bogotá. Critico d’arte e curatore del Padiglione Italia alla prossima Biennale d’Arte 2022 di Venezia, Eugenio Viola nel 2016 lascia, dopo sette anni, la curatela del Museo MADRE della sua Napoli natale per trasferirsi in Australia e da lì in Colombia, dove attualmente copre l’incarico di Capo Curatore del Museo de Arte Moderna de Bogotá – MAMBO.
Vestito di nero Eugenio si siede di lato, accavalla le gambe e i suoi occhi chiari e le sue mani vestite con grandi anelli dominano la scena. Malinconico di natura e obbligato all’ottimismo come dovere etico del nostro tempo incerto, dice en passant, come un sottotitolo di sé stesso il curatore partenopeo.
Ordineremo due bicchieri di vino rosso e parleremo di arte e del senso dell’arte in questo tempo. E pur essendo fisicamente al Nord sarà, per intenzione e calore e onorando le nostre origini, come il titolo del ciclo espositivo attualmente in mostra al MAMBO, una Conversación al Sur.
Mercedes Viola
#
Come ti trovi vivendo a Bogotá?
Posso vivere a Bogotá perché sono nato e cresciuto a Napoli. Probabilmente se fossi nato a Milano sarebbe stato diverso. Perché al di là delle differenze tra macro e micro, delle differenze geografiche: Napoli è una città sul mare mentre Bogotá è una città andina, entrambe sono sorrette da un’entropia che scorre sotto pelle, a tutti i livelli. Da una sorta di anarchia creativa. Entrambe vivono al limite. Si nutrono del loro limite. Ed è per questo che io mi sento a casa. Bogotá è la versione esplosa di Napoli, la sua versione sudamericana.
Ti interessa il Sud come concetto?
Il Sud è per me quasi una vocazione. Una parte ineliminabile del mio destino. Io sono nato al Sud, poi mi sono trasferito nell’emisfero sud, e adesso vivo in America del Sud.
Conversación al Sur (Conversazione al Sud) è il titolo dell’attuale ciclo espositivo al MAMBO. Di cosa si tratta?
È il dialogo tra tre artiste del Sud e un curatore del Sud e allo stesso tempo un omaggio alla fondatrice del museo: l’argentina

Marta Traba. Le artiste sono la cilena Voluspa Jarpa, che rappresentava il Cile nella scorsa edizione della Biennale d’arte a Venezia, uno dei migliori padiglioni, vincitrice dell’edizione inaugurale del Premio Julius Baer, il primo in tutto il continente sudamericano dedicato alle artiste latinoamericane, e le colombiane Luz Lizarazo e Alba Triana. L’opera della prima investiga la dimensione poetica e politica del femminino, quella della seconda indaga il limite tra visibile e invisibile attraverso un approccio umanistico alla tecnologia.
Come scegli gli artisti?
Dipende. L’artista ti dà la possibilità di guardare le lacerazioni, le inquietudini della contemporaneità, con uno sguardo strabico, differente, complementare rispetto a quelli della scienza e della politica. Scelgo gli artisti che si rapportano alla realtà in maniera dialettica e reagiscono, se necessario, in maniera anche polemica con la realtà.
Tra i curatori della mia generazione, in Italia, posso dire che sono quello che ha lavorato di più con artisti latinoamericani. Hanno una visceralità che a me è sempre piaciuta.
Hai lavorato in Italia, in Australia e ora in Colombia. Come cambia il processo di selezione da un paese all’altro?
È questa una responsabilità, una sfida molto grande: riconoscere e capire, in un contesto assolutamente estraneo a me – Colombia meno estraneo dell’Australia – che cosa può essere interessante per i visitatori. I musei sono, soprattutto, per il pubblico. È fondamentale individuare le emergenze tematiche che possano in qualche modo reagire, produrre senso, in un pubblico che ora conosco e mi segue, ma che non conoscevo all’inizio.
I grandi temi sono gli stessi per artisti sudamericani ed europei?
No, perché in genere l’artista parte dalla realtà che lo circonda e dopo, per induzione, il suo messaggio può giungere dal particolare al generale. Ti faccio l’esempio di un’artista guatemalteca con la quale ho lavorato molto e di cui ho curato l’antologica al PAC qui a Milano: Regina José Galindo (Estoy Viva, 2014). Tutto il suo lavoro si concentra sull’eccesso di violenza, soprattutto sulle donne, in Guatemala, ma per induzione propone una riflessione amara sull’eccesso di violenza che funesta la società contemporanea in generale.
Ho conosciuto il Guatemala prima di visitarlo attraverso la sua opera, così come ho conosciuto Cuba prima di visitarla attraverso l’opera di Carlos Garaicoa, con cui ho lavorato quindici anni fa a Salerno, invitandolo a partecipare ad una mostra sull’emergenza rifiuti.
Ho sempre optato per una curatela etica e impegnata nel sociale. Ora, per dove ho deciso di operare e rimanere, lo è ancora di più.
Adiamo indietro nel tempo. Come ti sei avvicinato all’arte?
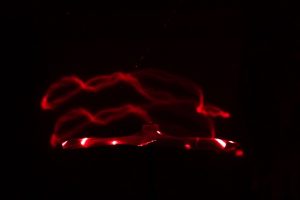
L’arte è una dipendenza, sono un artholic. Mi sono avvicinato all’arte grazie ai miei genitori. Mio padre invece di portarmi allo stadio la domenica, dove non sono mai entrato, mi portava ai musei. Ricordo ancora la prima opera d’arte contemporanea che ho visto nella mia vita: il Grande Cretto Nero di Burri, 1978 al Museo di Capodimonte, a Napoli. Era l’anno 1981, io avevo sei anni, e lo ricordo sempre perché mio padre, che era un intellettuale, mi aveva portato a vedere il Codice Atlantico di Leonardo, e mentre guardava l’opera di Burri mi diceva: Eugenio, io quest’arte contemporanea non la capisco.
Poi all’Università ho studiato Conservazione dei Beni Culturali e quando incontrai il mio maestro, Angelo Trimarco, mi sono lanciato sul contemporaneo.
Cosa risponderesti oggi a tuo padre?
Che non la devi capire. È una questione di sentire, di sensibilità. Poi ci sono vari livelli di approccio ad un’opera d’arte, anche di arte antica. Perché una composizione sacra la capisci, ma ci sono diversi livelli di lettura: il contesto, la presenza di simboli ermetici, rosacrociani, massonici, o tutta una serie di allegorie che in passato erano immediatamente riconoscibili ma che oggi, per noi, non lo sono più. L’uovo sospeso sulla testa della Madonna ne La Pala di Brera di Piero della Francesca, 1472, per esempio, era un simbolo d’immortalità immediatamente leggibile.
Il primo elemento di lettura in un’opera lo definisco ‘cosmetico’. Quello che senti d’impatto se una cosa ti piace, se ti sembra bella. Dopo c’è la parte estetica. Il contemporaneo non necessariamente ti deve piacere. L’importante è la reazione. Perché è l’indifferenza che ammazza tutto e anche l’arte. Spesso ho curato opere o progetti scomodi da guardare e da digerire, che non erano fatti per piacere, ma per generare una reazione.
È necessario conoscere l’autore di un’opera e sapere cosa voleva dire?
Non è necessariamente necessario. Ti dirò di più, io creo che un progetto, un’opera, una mostra, un padiglione, funzionano se tu, una volta finita l’esperienza della visione, hai più domande che risposte. Se questo succede, significa che l’esperienza ha funzionato.
Parlando di padiglioni c’è una domanda che ti devo fare.
Se posso rispondere…
Eugenio Viola, curatore del Padiglione Italia alla Biennale d’Arte 2022 di Venezia, sceglie un solo artista (Gian Maria
Tosatti). Perché?
Ho sostituito lo schema trinitario adottato dai miei predecessori, con un artista che invece è uno e trino. Semplice. (ridiamo)
Quando sono stato invitato a presentare un progetto per il Padiglione Italia, la mia scelta è stata immediata. Ho lavorato molto

con Gian Maria Tosatti a Napoli. Lui, come me, lavora per cicli. Infatti, non ho una mostra preferita tra quelle che ho curato, perché tutte fanno parte di un discorso in divenire, come capitoli diversi di un romanzo per immagini. Con lui avevo lavorato a Napoli ad un grande progetto durato tre anni: più che un progetto, una saga curatoriale (Sette Stagioni dello Spirito, 2013-2016). Un grande romanzo visivo di formazione, attraverso il quale abbiamo restituito alla città sette edifici monumentali dismessi, dalla seconda guerra mondiale o dal terremoto dell’80. Tosatti è un artista che ha un grande dominio dello spazio. Un visionario.
Credi che la pandemia abbia accomunato a livello mondiale le necessità, i temi di conversazione?
Su alcuni temi, sì, poi ci sono differenze specifiche. In Colombia il problema non è la pandemia in sé, ma l’emergenza sociale. La gente ha fame, e la fame genera rabbia, sempre.
E in luoghi con emergenze così elementari, è necessaria l’arte? Quale funzione compie?
Educa. Nutre lo spirito. Con il museo dobbiamo colmare molti gaps lì in Colombia. L’educazione è uno di questi. E l’arte educa, ti porta a riflettere e ti può dare una visione differente sui problemi. È per questo che i regimi autoritari la guardano con diffidenza. Guarda cosa sta succedendo a Cuba con gli artisti che entrano ed escono di prigione.
Pertanto, sí, è assolutamente necessaria. Al MAMBO portiamo avanti una serie di programmi per le persone disagiate, come il “MAMBO Viajero”, un museo itinerante che mira a democratizzare l’arte e che gira con estratti di alcune esposizioni nelle aree più problematiche del paese. Sono da sempre un grande sostenitore dell’osmosi tra l’esterno e l’interno dell’istituzione. Organizzo frequentemente progetti urbani, virali nel senso positivo del termine.
E l’arte pubblica?
Lo stesso. Quando è di qualità, e non sempre accade, l’arte pubblica è un modo di avvicinare anche i non addetti ai lavori agli artisti contemporanei. L’arte può avere il potere di risvegliare le coscienze, di generare processi di rigenerazione sociale e culturale che possono svilupparsi precisamente a partire da una dimensione urbana, sociale, collettiva e partecipativa.
Nell’arte contemporanea, come fai a sapere cos’è arte e cosa non lo è?
Me lo dice il mio stomaco. Ora mi è molto più facile, lavoro da più di vent’anni e ho l’occhio e il muscolo della percezione allenati.
Poi intervengono nella valutazione livelli differenti: il rapporto con il contesto, sapere a chi si è ispirato l’artista, ma questo non deve essere necessariamente l’argomento di un pubblico più generale che viene semplicemente per vivere un’emozione, o per andarsene disturbato.
Come vivi la critica?

Accetto le critiche se sono costruttive. L’arte deve creare dialogo, dibattito. Questo è il compito dell’arte oggi, altrimenti non avrebbe più ragione di essere. Viviamo in una società iper-estetica che rischia di anestetizzarci. Tutto è estetico: i videoclip, i trailer del cinema, la politica, la vita stessa. Siamo sommersi, inondati da una quantità di stimoli visivi come mai prima. Un processo sclerotizzato dalla rivoluzione digitale. Quindi, è importante che ci sia una reazione, anche se di disgusto, di fastidio.
Si rischia di dovere alzare sempre il tiro?
Io non sono un sostenitore dello scandalo fine a se stesso. Può essere strumentale in un determinato contesto ma si rischia che lo scandalo vada a fagocitare l’opera stessa. Preferisco dare spazio alla provocazione intelligente. Poi quello che risulta scandaloso è soggettivo, dipende da chi lo guarda. Come diceva San Paolo: Omnia munda mundis. Tutto è puro per i puri.
La tua Napoli qual è?
La mia Napoli è quella del pensiero, degli intellettuali, illuminista, cosmopolita e liberale. L’oleografia mi interessa meno. Ho lavorato per sette anni al MADRE, il museo di arte contemporanea della mia città, ed ho sempre cercato e mi sono concentrato per offrire una visione diversa da quella dell’oleografia legata all’immagine di Napoli: pizza – mandolino – rifiuti. Sono un napoletano atipico e ho con la mia città un rapporto ambivalente di amore – odio. Napoli è come Medea.
Ti ha mai intrigato il Nord?
Sí, il suo aspetto antitetico e complementare a quello del Sud. Sono le due facce della stessa moneta. ‘Nel nord il sud e nel nord il sud’, come diceva Walter Benjamin. Milano è la mia seconda città in Italia, e – dopo Napoli, la mia città preferita. Probabilmente è l’unica città d’Italia oggi ad essere veramente europea. Se vivessi in Italia probabilmente vivrei qui, anche se ritengo Napoli molto più bella e intrigante di Milano, nonostante tutte le sue innegabili criticità.
