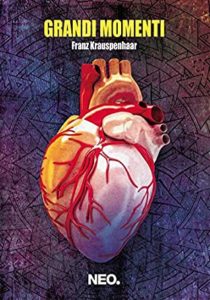 “Sto camminando per una rampa di scale di metallo, fino a una specie di cantina che sta all’ultimo piano di un palazzo costruito obliquo. Dalle finestre vedo uno strano panorama. Poche auto. Piccole. Il cielo di un colore sicurissimo, e il sole dietro, che si protende verso le tenebre.”
“Sto camminando per una rampa di scale di metallo, fino a una specie di cantina che sta all’ultimo piano di un palazzo costruito obliquo. Dalle finestre vedo uno strano panorama. Poche auto. Piccole. Il cielo di un colore sicurissimo, e il sole dietro, che si protende verso le tenebre.”
In questo passaggio esoterico Franz Krauspenhaar nel suo romanzo Grandi momenti (edizioni Neo) rileva che questa realtà ha un doppio binario che solo la malattia può decifrare, che solo la psicosi ha la facoltà di sgombrare dalle cortine che ne nascondono l’essenza, ossia la scoperta che la vita è anche morte, il reale presente è anche immanente di reminiscenza, il mondo dei vivi ogni giorno si mischia ai morti, la felicità non può esistere a fronte di una tale immensità diacronica, di piani inclinati tra presente e futuro in cui lo stesso principium individuationis è negato alla radice, “nel pensier mi fingo; ove per poco il cor non si spaura”, avrebbe detto il Leopardi.
Franz insegue qui un non senso di un universo che non lascia spiragli di luce alla sua oscurità, da qui il mistero che affligge ogni aspirazione di chiarezza.
Grandi momenti è il romanzo della disperazione che non trova sfogo, nonostante la passione delle donne, per le automobili vintage, per le birre tedesche e fiamminghe, nulla solleva dal fardello dell’esistenza il protagonista, Franco, reduce da un infarto, frequentatore di una clinica riabilitativa dove si concentrano i suoi amici più fedeli, tutti sopravvissuti alla malattia come lui, tutti in riabilitazione e alle prese con assunzioni quotidiane di farmaci salvavita.
Franco è uno scrittore scriteriato che guadagna solo sotto pseudonimo per scrivere una serie di noir coi quali è ricco per la prima volta ma che lo lascia basito sul proprio valore letterario, Franco senza appelli, che trova pace e rifugio solo nella convivenza con la madre (il Colonnello) e il fratello Ernesto, ma che non può superare il segno indebito e indelebile di una speranza che è morta e che lo assale senza requie in qualsiasi contesto, nelle visioni del padre morto che gli compare come una lepre enorme che fugge a balzi tra le strade di Milano, nella consapevolezza lucidissima di un paese che odia, di una società dei consumi che detesta, di una Milano multirazziale e impoverita, senza slanci, senza futuro che non sia questo degenerare globalizzato dove come Marx aveva previsto ogni essere è divenuto merce o è già un prodotto avariato, per Franco lo stesso senso della storia pare essersi fermato dentro l’asfissiante dominio del Nulla heideggeriano che segue di quattro lustri il concetto tragico così circostanziato da un Nietzsche redivivo in una lucidità persino oracolare nel suo Il nichilismo europeo (Adelphi).
Franco qui si destreggia su due piani inclinati, quello della conservazione dei suoi appetiti, delle sue passioni giovanili, il secondo, quello dell’ingresso nolente e dolente verso un universo sconosciuto, diacronico, ctonio come direbbero i Greci di Micene, ciò che è terreno ma che domina ancestrale e istituzionale, la natura sconosciuta implacabile, ciò che è stato che è ancora e sarà, ciò che è terreno ma inaudible, invisibile, ma immanente dentro l’esortazione della vita, l’eterno che si compie pedissequamente come negazione della vita ma anche come suo complemento e contraltare per cui tutto ciò che vive trova vigenza o meno. Dove non esiste pietà né pietismo, dove ogni religione, ogni ideologia si scioglie come grumi di sale grosso nell’acqua, propiziando unicamente un tasso di salinità che trasforma questa acqua ancora di più in una risorsa non commestibile alla sete mai esausta e mai esauribile dell’uomo.
Libro che ho trovato delizioso nonostante il senso di spaesamento che lascia, perché non demorde mai da un senso autentico di ironia, se non di sarcasmo, di aperto cinismo, in cui nonostante sia rappresentato un mondo di derelitti, di derelizione di una intera civiltà che Pasolini aveva così efficacemente previsto sessanta anni prima, rimane viva uno scudo di fierezza che sa anche irriderlo questo mondo insensato, irroderlo di una feroce faticosa comprensione, dove rilevo pure un rimasuglio di profonda pena, di amore per la vita al di là dello sfacelo.
Franz Krauspenhaar mi ricorda Bukowski per il disincanto e lo stile essenziale, il ritmo rapido, ricorda la disperazione di un Emil Cioran, senza requie, senza ripari all’incombere della storia e della inciviltà fattasi globale, ricorda Henry Miller per un certo machismo, per il politically incorrect di certe affermazioni, un libro che va assolutamente letto, letto d’un fiato, per lasciarsi sopraffare dal ritmo di questa che si rileverà una discesa nell’inferno, onesta e temeraria, dove ciascun lettore si troverà solo con sé stesso, senza appigli che non sia un senso cosmico dell’orrore. Questo orrore che è vivere in un tempo che è stato abolito, divenuto unicamente il confine ad absurdum di un vivere che non è che resistere alla sua inclemenza fattasi plateale, dentro una storia divenuta farsa.
Franz Krauspenhaar è indubbiamente uno degli scrittori più importanti ma anche più misconosciuti in Italia, il cui merito andrebbe rivalutato, uno scrittore capace di tenere la rotta dove la letteratura dovrebbe dirigersi ossia verso la verità del nostro tempo, qualsiasi verità debba scaturirne fuori. Anche la più abissale. Qui oggi gli rendiamo questo merito.
Marcello Chinca Hosch
