
Il Veneto di Shakespeare?
Quello soltanto immaginato, “una dimensione di fantasia” potremmo dire per arrivare subito alla conclusione. Perché, in barba a tutti coloro che favoleggiano su presunte diverse identità e vite parallele, Shakespeare in Italia, e in Veneto, non c’è mai stato. Certo, ne ha avuto notizia, fonti differenti e non esigue, ma in quanto al resto Shakespeare era solo un geniale drammaturgo, un uomo di teatro che sapeva mettere a frutto le voci che sentiva e raccoglieva tutte nel grande orecchio da cui si lasciava incantare per dar forma alle parole, le sue, e alle immagini che ne sgusciavano fuori.
Ne è convinto, Sergio Perosa, che al grande Bardo ha dedicato tutta la vita e ancora si sveglia di notte domandandosi se un verso possa essere reso in un modo piuttosto che, più esattamente, in un altro. È convinto che non gli si possa rendere giustizia se non lasciando spazio alle sue creazioni, così come sono, senza chiedersi chi sia stato il suo creatore, inventandosi più di quanto abbia già fatto lui. Si andrebbe lontano, troppo, mancando il bersaglio, costituito da quel prezioso serbatoio di parole che ci descrivono l’uomo, non l’uomo Shakespeare, ma l’uomo che ognuno di noi, indipendentemente dal genere, incarna e sa far suonare in un’unica nota che si moltiplica all’infinito e che, moltiplicandosi, si spezza e si rincorre, creando melodia. Una melodia che suona cupa, in certi casi, molti, ma che sa anche aprirsi in un ventaglio amoroso che ci strugge e ci appassiona. Come nel caso dei drammi veneti che Perosa ha tradotto, il più famoso dei quali è ambientato a Verona ed è ancora sinonimo di un amore contrastato e tragico, lirico e tragico, come solo la giovinezza sa creare.
domandandosi se un verso possa essere reso in un modo piuttosto che, più esattamente, in un altro. È convinto che non gli si possa rendere giustizia se non lasciando spazio alle sue creazioni, così come sono, senza chiedersi chi sia stato il suo creatore, inventandosi più di quanto abbia già fatto lui. Si andrebbe lontano, troppo, mancando il bersaglio, costituito da quel prezioso serbatoio di parole che ci descrivono l’uomo, non l’uomo Shakespeare, ma l’uomo che ognuno di noi, indipendentemente dal genere, incarna e sa far suonare in un’unica nota che si moltiplica all’infinito e che, moltiplicandosi, si spezza e si rincorre, creando melodia. Una melodia che suona cupa, in certi casi, molti, ma che sa anche aprirsi in un ventaglio amoroso che ci strugge e ci appassiona. Come nel caso dei drammi veneti che Perosa ha tradotto, il più famoso dei quali è ambientato a Verona ed è ancora sinonimo di un amore contrastato e tragico, lirico e tragico, come solo la giovinezza sa creare.
Sono dunque “”a local habitation and a name”, una dimora locale e un nome, a quell'”airy nothing”, a quel nulla fatto d’aria, che sono per lui anche i luoghi, pur così presenti, dei suoi drammi”. Sono l’occasione e l’escamotage per parlare della sua Inghilterra, facendo finta di parlare di una terra “esotica” come l’Italia, sentita, allora, in maniera duplice e schizofrenica: una sentina di vizi, vista l’aborrita presenza del Papato, e la culla della civiltà e della raffinatezza, qual era Venezia, quella dei Dogi, affine, molto, all’Inghilterra di Elisabetta I. Venezia la Ricca, la Saggia, la Giusta, Venezia la Galante, come riassume David McPherson, citato da Perosa. L’alleata migliore per Elisabetta che amava e parlava perfettamente la nostra lingua e nel 1583 fondò la “Venice Company” per i rapporti commerciali con la Signoria.
Si faceva quindi un gran parlare di cose italiane, nella Londra di quel tempo, e Shakespeare, oltre che per le chiacchiere che raccoglieva per strada, nelle locande e nei teatri, poteva contare sulle sue personali fonti: John Florio, appartenente anch’egli alla cerchia del Conte di Southampton, autore del primo dizionario italo-inglese; Vincenzo Saviolo, maestro di scherma residente a Londra, che forniva, con il suo manuale, abbondante e prezioso materiale per i duelli di scena; i musicisti italiani Bassano. Ma il punto è questo: che “egli operò la sintesi grazie all’inventiva e alla capacità di vedere l’uomo e il suo dramma ovunque, in zone intermedie fra strapaese e cosmopolitismo, fra realtà nazionale ed esotismo, come fa sempre il grande artista; grazie, ripeto, alla strana legge jamesiana del minimo di suggerimento che permette all’artista il massimo di sfruttamento (e, forse, viceversa)”.
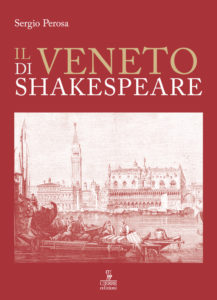 Sergio Perosa, con il suo Il Veneto di Shakespeare (Cierre edizioni, 2018, pp. 141, euro 12), ci porta nella Verona de I due gentiluomini e di Romeo e Giulietta, nella Padova de La bisbetica domata e poi nella Venezia del Mercante e di Otello, tutte incredibilmente in bilico tra il colore locale, la precisione del dettaglio, e l’indefinita atmosfera che, di sponda, descrive un sapore tipicamente inglese ed elisabettiano.
Sergio Perosa, con il suo Il Veneto di Shakespeare (Cierre edizioni, 2018, pp. 141, euro 12), ci porta nella Verona de I due gentiluomini e di Romeo e Giulietta, nella Padova de La bisbetica domata e poi nella Venezia del Mercante e di Otello, tutte incredibilmente in bilico tra il colore locale, la precisione del dettaglio, e l’indefinita atmosfera che, di sponda, descrive un sapore tipicamente inglese ed elisabettiano.
Solo qualche parola sulla Venezia dei mercanti- “the market-place of the world”, il mercato del mondo, secondo la definizione di Coryat- con Rialto a fare da cassa di risonanza mediatica della città, e, in contrappunto, quella dei giovani impegnati in balli e mascherate nei lussuosi palazzi del patriziato. Venezia mercantile e capitalistica, Venezia tollerante, ma con mire precise ossia il vantaggio, Venezia lussuriosa e carnascialesca. E l’altra Venezia, quella di Belmonte, lo scenario delle ville palladiane di terraferma dove “l’aristocrazia commerciale veneziana va a consolidarsi come aristocrazia di consumo, a ritrovar pace, ad affogare l’attivismo o a perdere consistenza”. Il contrario del mito romantico che fa della città l’oasi del sogno mentre la terraferma è vista come luogo della realtà e degli affari, osserva acutamente Perosa.
Ma che ne è di Venezia, oggi?
Lo dico con Javier Marias. E perché, mi si chiederà? Perché a me piace sempre “buttarla in Marias”, un po’ per predilezione e un po’ perché troppo addentro, lui, alle faccende shakespeariane. Anche se in questo caso Shakespeare c’entra poco, ma Venezia c’entra eccome.
Mi rifaccio, allora, al suo Venezia, un interno (Mavida, 2012, euro 25) in cui lo scrittore- che in città ha  passato lunghi periodi della sua vita, non i tre cinque o sette giorni mordi-e-fuggi del classico turista dei nostri giorni– ci restituisce un sapido bozzetto dell’attuale Venezia, assediata dall’orrida fiumana dei saccopelisti (i giovani) e da quella dei “sedia a rotelle” (i vecchi), con cui il residente, quell’essere strano che in città abita permanentemente, deve fare i conti e a cui deve cedere le sue strade, rassegnandosi a transitare per una “città recondita”, non “quella che sogna tutto il resto del mondo, ma pareti scalcinate e rotte, ponti minuscoli sopra canali esili e senza gloria, lo scortecciato e crepato sfondo della città, la sua ombra, in cui non esistono negozi né alberghi né ristoranti né bar, ma solo gli elementi essenziali, la pietra e l’acqua”. Di vitale importanza diventa allora inventare uno spazio alternativo in cui ritrovarsi intatti e inviolati, la spiaggia del Lido come la platea della Fenice. D’altronde, Venezia, “risolta in modo che la sua immutabile superficie o figura coincida solamente con quel che è principale, sparge sulla laguna tutto quanto risulti troppo specializzato o troppo vergognoso, il sussidiario, l’orrendo, il funzionale, il malato, ciò che non si deve vedere, ciò che non deve avere spazio nel suo corpo amministrativo, ecclesiastico, palatino, navale, commerciale”. Venezia è il suo punto di vista sull’eternità, una città immodificabile, se non negli elementi umani, che ha nel passato tutto il suo futuro. Venezia era, è, e sarà sempre quella. È un interno, come aveva capito Henry James e come dice Marias: “Significa che è sufficiente, che all’infuori di essa non si ha bisogno di altro e che questa stessa mancanza di necessità è ciò che crea la sua inesauribile frammentazione ideale: l’ampliamento di ciò che è angusto, la lontananza di ciò che è vicino, l’infinitezza di ciò che è limitato, la differenza di ciò che è identico, il trascorrere di ciò che è senza tempo”.
passato lunghi periodi della sua vita, non i tre cinque o sette giorni mordi-e-fuggi del classico turista dei nostri giorni– ci restituisce un sapido bozzetto dell’attuale Venezia, assediata dall’orrida fiumana dei saccopelisti (i giovani) e da quella dei “sedia a rotelle” (i vecchi), con cui il residente, quell’essere strano che in città abita permanentemente, deve fare i conti e a cui deve cedere le sue strade, rassegnandosi a transitare per una “città recondita”, non “quella che sogna tutto il resto del mondo, ma pareti scalcinate e rotte, ponti minuscoli sopra canali esili e senza gloria, lo scortecciato e crepato sfondo della città, la sua ombra, in cui non esistono negozi né alberghi né ristoranti né bar, ma solo gli elementi essenziali, la pietra e l’acqua”. Di vitale importanza diventa allora inventare uno spazio alternativo in cui ritrovarsi intatti e inviolati, la spiaggia del Lido come la platea della Fenice. D’altronde, Venezia, “risolta in modo che la sua immutabile superficie o figura coincida solamente con quel che è principale, sparge sulla laguna tutto quanto risulti troppo specializzato o troppo vergognoso, il sussidiario, l’orrendo, il funzionale, il malato, ciò che non si deve vedere, ciò che non deve avere spazio nel suo corpo amministrativo, ecclesiastico, palatino, navale, commerciale”. Venezia è il suo punto di vista sull’eternità, una città immodificabile, se non negli elementi umani, che ha nel passato tutto il suo futuro. Venezia era, è, e sarà sempre quella. È un interno, come aveva capito Henry James e come dice Marias: “Significa che è sufficiente, che all’infuori di essa non si ha bisogno di altro e che questa stessa mancanza di necessità è ciò che crea la sua inesauribile frammentazione ideale: l’ampliamento di ciò che è angusto, la lontananza di ciò che è vicino, l’infinitezza di ciò che è limitato, la differenza di ciò che è identico, il trascorrere di ciò che è senza tempo”.
Un interno e una dimensione prettamente letteraria, vicina e lontana, differente e identica; come è il Veneto di Shakespeare, il suo punto di vista sull’eternità!
