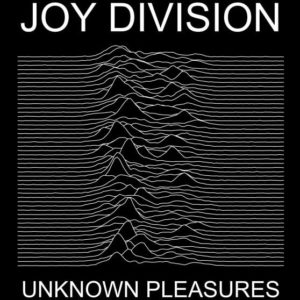
Al basso con i Joy Division prima e al basso e alla batteria elettronica con i New Order poi, ha scritto alcune delle pagine più importanti del rock e non solo degli ultimi 40 anni. Con il passaggio da live venue a dance club dello storico locale di Manchester Haçienda, è tra coloro che ha lanciato l’acid generation e una nuova cultura della musica dance e dintorni. Insomma, a sessantatré anni Peter Hook potrebbe tranquillamente considerarsi una leggenda che cammina. Invece, come sempre dovrebbe essere, è rimasto il ragazzo estroverso, simpaticissimo e pieno di voglia di fare che, partendo dai sobborghi meno abbienti della città mancuniana, ha sfondato vivendo una vita intensissima e perennemente sulla corsia di sorpasso.
Lo abbiamo incontrato poco prima dell’affollata presentazione del suo libro, “Haçienda. Come non si gestisce
un club” (Luiss University Press, collana: Stories, 2019, pp.380, € 24), dedicato proprio all’incredibile storia del locale di Whitworth Street West e finalmente disponibile anche in Italia.
A distanza di dieci anni dalla pubblicazione del volume e a oltre venti dalla chiusura del locale, che eredità musicale e culturale ha lasciato Haçienda?
In una sola parola: enorme. Soprattutto dal punto di vista musicale. Qualsiasi cosa è venuta fuori in quest’ultimo quarto di secolo, ha fatto tesoro di quello che è stato suonato dai gruppi e dai dj anni fa all’interno di quelle mura. Beyoncé, Taylor Swift, come la maggior parte del rock alternativo, la dance, la house: viene tutto da quell’esperienza lì, non ci sono dubbi.
Quando hai scritto il tuo primo libro, hai avuto difficoltà nel passare dalle quattro corde e dalla batteria elettronica alla tastiera di un computer? O avevi già fatto dei tentativi precedenti?
Prima di farlo, la mia unica esperienza era stata quella di un blog, che ai tempi andavano molto forte. Cosa mi ha convinto al “grande salto”? le insistenze di un mio amico, che adesso fa il militare e che, ai tempi, stava curando la ristampa di un disco dei New Order. Quando lesse le note di copertina che avevo preparato, mi disse: “Tu questa storia la devi raccontare tutta!”. Ed è quello che ho fatto. Chiaramente il passaggio da un format di scrittura comunque meno impegnativo a un libro vero e proprio non è stato certo facile o lineare. Contrariamente alla musica, ci ho messo davvero tanto a trovare non dico una mia “maniera” ma un modo corretto di procedere. Poi, lentamente, ho cominciato a migliorare, ad avere più…padronanza, ecco sì. Tieni presente che questo libro l’ho riscritto qualcosa come trecento volte! Invece quello sui Joy Divsion e quello sui New Order di meno, solo duecento e cento volte (ride, ndr), sono molto migliorato! No, a parte gli scherzi è stato un lavoro molto duro, ma mi ha regalato delle soddisfazioni uniche. Per me, è facile incontrare qualcuno che sta ascoltando una canzone delle band di cui ho fatto parte quando vado in giro per il mondo, ma è un’emozione di tutt’altro tipo incontrare qualcuno con un mio libro in mano. E mi è successo un sacco di volte, in tanti aeroporti dove sono passato per andarlo magari a presentare da qualche parte, visto che è stato tradotto in quindici lingue. Venire a farlo qui in Italia, per esempio, è una cosa meravigliosa, io adoro questo paese e la sua gente e sono chiaramente orgoglioso di essere considerato anche come autore, oltre che come musicista. Tra l’altro, la storia che racconto è davvero irresistibile. È così piena di avvenimenti strani, meravigliosi, a volte anche ridicoli che non può proprio lasciare indifferenti. E la cosa più bella è che, per quanto possa sembrare incredibile, sono è tutto vero! Ah, e un’altra cosa prima che me ne dimentico: mia madre, oggi sarebbe orgogliosa del fatto che scrivo libro. Non lo era molto, invece, di quando suonavo in una punk band. Pensa che lei ricordava solo i pezzi dei primi Cure e, all’inizio degli anni Ottanta, c’era una bella rivalità tra noi New Order e loro (ride di nuovo, ndr)!
Dopo aver raccontato dall’interno le vicende dei tuoi gruppi e l’avventura umana e culturale di uno dei più grandi locali di tutti i tempi, non ti è mai venuta voglia di cimentarti con la narrativa?
Oh sì, certo, soltanto che non è facile, bisogna innanzitutto trovare il coraggio di farlo. Ti dico così perché è da diverso tempo che cullo il sogno di scrivere un romanzo ispirato alla vita di uno dei miei più cari amici, Howard Marks (fisico ed ex trafficante internazionale di droghe leggere, reso celebre dal libro autobiografico Mr Nice, da cui nel 2010 Bernard Rose trasse un film interpretato da Rhys Ifans, ndr) ma ancora non riesco a decidermi a confessarglielo! La sua è stata davvero una vita larger than life e sarebbe bello ispirarsi ad essa per un’opera di fiction. Vediamo un po’ se succederà in futuro…
Alcuni addetti ai lavori, hanno paragonato il tuo stile a quello di Irvine Welsh. Cosa ne pensi e apprezzi il “figlio prediletto di Leith”?
Certo che lo apprezzo! Irvine è un amico, tra l’altro. Pensare di essere paragonati a lui fa un certo effetto, è una cosa piuttosto…”dura”. Lui è un fuoriclasse della narrativa mondiale, non uno qualsiasi. Penso che questo accostamento, comunque, nasca soprattutto dal fatto che, seppur in ruoli e in tempi diversi, abbiamo vissuto entrambi un certo tipo di vita (non del tutto “onorevole”, direi).
La Manchester che racconti è forse, insieme a Bristol con la scena trip hop e street e a Seattle con il grunge, una delle ultime città ad aver creato una scena musicale e culturale tout court pur non essendo una metropoli. Perché oggi, secondo te, è così difficile che si verifichino fenomeni simili?
Io penso che le colpe maggiori, in questo senso, siano da addebitare all’esplosione di internet perché rappresenta, nello stesso tempo, un collettore e un distruttore di idee che non permette alle cose dei tempi di incubazione e di emanazione giuste. Oggi, a livello musicale e culturale, tutto va a finire in un gran calderone e ne viene rapidamente sputato fuori senza che ci sia quasi mai la possibilità di durare nel tempo. Non bisogna poi dimenticare che in questi ambiti, rock in particolare, è stato fatto moltissimo, forse tutto. O forse sarà che sto diventando vecchio e quindi non riesco ad essere più ottimista come tanti anni fa, non so. In ogni caso, visto che spesso come gruppo o come esponenti di un “modello” del passato che ha avuto successo siamo stati criticati anche a casa nostra, anche a Manchester, io rispondo a coloro che lo fanno, a volte anche con piglio particolarmente agguerrito: “Beh, pensateci voi al futuro, invece di star sempre lì a lamentarvi di noi, no?”.
Cosa ne pensi del racconto dell’epopea dell’Haçienda fatto da Winterbottom nel suo “24 four hour party people” del 2002?
All’inizio, io credo che Winterbottom abbia pensato che la storia di quel locale fosse tutta una farsa, qualcosa di ridicolo. Poi, invece, è rimasto sbalordito nel costatarne la veridicità e ha girato un film che non mi dispiace affatto, anche se, per dire, rispetto a un Control (una pellicola del 2007 diretta da Anton Corbijn incentrata sulla vita dell’iconico leader dei Joy Division Ian Curtis, ndr) è certamente meno rigoroso. In ogni caso, visto che in quel lavoro si parla anche della mia vita, come in Control, d’altronde, posso dire di essere felicissimo che sia stata così intensa e folle da poter aver ispirato ben due film. E sono ovviamente felicissimo di essere ancora qui a poterla raccontare io stesso. Aspettiamo un terzo movie, dai (ride, ndr)!

Insieme ai tuoi compagni storici di avventura Bernard Summer e Stephen Morris (e naturalmente, per quanto riguarda i Joy Division, anche al compianto Ian Curtis), hai dato vita a due dei gruppi più influenti nella storia della musica, partendo da una condizione sociale non certo agiata. Considerando il funzionamento dell’industria musicale-culturale di oggi e il suo mercato di riferimento, credi che un ventenne nel 2019 possa ancora sognare di fare una “scalata” simile alla tua?
Anche se abbiamo ricevuto già nei primi anni di attività con i Joy Division degli ottimi riscontri, posso assicurarti che la nostra “scalata”, come la chiami tu, è stata davvero molto lunga e molto dura. Di certo mi ha aiutato molto il fatto di provenire da ambienti proletari dove lo spirito battagliero e l’essere temprati ai rovesci della sorte sono qualità che fanno parte del tuo DNA fin da bambino. E di certo mi ha, ci ha molto aiutato anche il fatto di essere sempre rimasti con i piedi per terra ed aver fatto praticamente zero compromessi per arrivare al successo, come ben esemplifica la nostra esperienza in ambito discografico con un’etichetta come la Factory Records, che ci ha dato e tolto in modo non convenzionale, come avrete modo di scoprire leggendo questo libro su Haçienda. Certo, ci vuole poi anche fortuna, noi ne abbiamo avuta e non poca, ma è anche vero che la volontà non è un fattore trascurabile: quando vidi i Sex Pistols e Johnny Rotten la prima volta, capii che quello che stavano facendo su un palco era esattamente quello che volevo fare, pur dovendo partire da zero. Ed è esattamente quello che ho fatto. È necessario avere volontà e saper sognare, essere sempre visionari, anche nei momenti più bui. Ad esempio, ed è una cosa alla quale al tempo avevo valutato, come sarebbe stata la mia vita se dopo la morte di Ian nel 1980, avessi mollato con la musica? Bisogna andare avanti, trovare motivazioni, avere, più in generale, sempre il coraggio di provare a fare le cose in cui si crede fino a consumare l’ultimo grammo di energia che si ha. Questo è quello che conta più di tutto. Ieri come oggi.
Nel giugno di quest’anno, è ricorso il quarantennale dalla pubblicazione di “Unknown pleasures”. Come musicista, lo consideri il vertice della tua carriera o credi che abbiano avuto più importanza “Closer” sempre dei Joy Division o anche “Power, corruption and lies” dei New Order?
Non mi riesce, né mi è mai riuscito di categorizzare la musica, che io vedo invece come un continuum in evoluzione, che non guarda mai troppo dietro. Quello che faccio adesso con i Monaco, per esempio, mi eccita e soddisfa enormemente. Se penso ai Joy Division, che pure ho celebrato risuonandoli più volte dal vivo con i The Lights, o ai New Order, io credo che ci siano dei momenti che non possono tornare in eterno. Volendo fare un paragone letterario e richiamando Welsh, si potrebbe dire che è come se tu volessi accostare i primi romanzi della produzione di Irvine con quelli di adesso. Ci sono delle differenze di esperienza, di maturità, di… tutto!, che non possono essere non evidenti.
Chi sono gli scrittori preferiti di Peter Hook e che cosa tieni sul comodino in questo momento?
Beh, leggo moltissimo e mi piacciono molti scrittori. Adesso, te ne nomino giusto un paio, John Irving (forse il mio preferito) e Lee Child. Mentre sul libro che amo di più, non ho dubbi: “Tenera è la notte” di F.S. Fitzgerald, l’unico che ho riletto più volte e al quale con i New Order abbiamo dedicato una canzone, “Leave me alone”. Ah, ma lo sai che proprio in questi giorni ho rubato dalla piccola libreria del mio albergo romano Pat Tense (ride, ndr)? Comunque, al momento, prima di spegnere le luci, leggo le storie di zombie di David Wellington. Ne convengo, non sarebbero proprio il massimo prima di dormire, ma mi piacciono moltissimo, non posso farci niente (ride ancora, ndr)!
