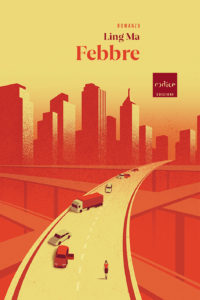
Si può scrivere un altro romanzo apocalittico nell’era dell’ipersaturazione di apocalissi annunciate, promesse, descritte o solo immaginate?
La risposta è ovviamente sì, quel che è meno ovvio è riuscire a costruire un romanzo che non sia la ripetizione di schemi ormai già imbolsiti, prevedibili e scontati perché già fin troppo usati.
Ling Ma ci è riuscita con Severance (Febbre, trad. it. Anna Mioni, Codice, 2019), che si smarca dalle solite strutture un po’ scolastiche del genere, nonostante poi finisca per somigliare un po’ a Walking Dead, ma quello del cortocircuito con le serialità televisive è un problema che hanno tanti libri di generi diversi: Country Dark di Offutt sembra troppo vicino a un episodio di Justified, Whiskey di Bruce Holbert si muove sulla scia di Bloodline, la saga di Panowich strizza l’occhio a immaginari ormai ufficialmente associati ai fratelli Coen e loro derivati come Fargo, The Mars Room paga un debito forse involontario nei confronti di Orange is the New Black, ma forse Rachel Kushner e Jenji Kohan hanno solo avuto la stessa idea più o meno nello stesso momento, così come è accaduto a Taylor Jenkins Reid che stava scrivendo Daisy Jones and the Six mentre altrove si stava girando A Star is Born, e a Melissa Broder che stava scrivendo The Piscesmentre qualcuno stava già sceneggiando The Shape of Water.A volte si tratta di sceneggiature spurie, come il caso di Offutt, o di vero e proprio materiale per una serie tv, com’è il caso di Panowich, in ogni casi si tratta di migrazione di idee, di idee che nascono nello stesso brodo culturale, dal medesimo immaginario ormai edificato non solo da libri, ma anche da serialità televisive, film e persino videogiochi.
La cosa curiosa è che Severance inizia proprio con il riconoscimento che tutto era già “fatto nei film” sebbene poi le cose nella realtà del libro “si erano rivelate diverse dal modo in cui erano state rappresentate al cinema.” Questo perché film, serie tv, romanzi e racconti a tema apocalittico e post-apocalittico tendono a rimestare un po’ gli stessi elementi e finiscono spesso per diventare una simulazione, un esperimento mentale in cui si applicano, a seconda dei casi: una versione infantile del marxismo in cui ricchi e poveri si dividono e si crea una lotta di classe su altra scala (un esempio recente è The Book of Joan di Lydia Yuknavitch, che però aggiunge all’equazione una buona dose di weird e femminismo), un teatrino hobbesiano con Stato di Natura, homo homini lupus, con tanto di Leviatano (The Walking Dead, a più riprese, The Flame Alphabet di Ben Marcus) o senza Leviatano (The Road di Cormac McCarthy, con quell’immagine iniziale nella quale il padre sogna di una bestia sotterranea, di un “lago nero e antico,” che “dondolava la testa appena sopra il pelo dell’acqua come per annusare ciò che non riusciva a vedere,” scena che può ricordare la bestia biblica da cui Hobbes trae il titolo del suo trattato), una versione del solito darwinismo frainteso (ancora The Walking Dead), una qualche versione del mito del buon selvaggio di Rousseau, un’applicazione del contratto sociale di dei trattati sul governo di John Locke (Zone One di Colson Whitehead, o serie tv come Jericho o Revolution) o ancora le solite applicazioni del dilemma del prigioniero (in modo tutto sommato banale suThe Dreamers di Karen Walker Thompson, o fin troppo articolato sulla serie tv The 100), o un misto di tutte queste cose (come nel racconto “Speech Sound” di Octavia Butler).
Severance esce dalla logica del compitino filosofico, dove cerchi il candidato di illustrare i meccanismi sociali che entrano in azione in uno scenario post-apocalittico: perché e come un gruppo di persone che improvvisamente si trova senza gli agi di una società organizzata deciderà di ricrearne una. O perché e come non lo farà.
Severance parte da un assunto marxiano abbastanza forte, ma ormai non più solo marxiano (si pensi a Naomi Klein), dell’incompatibilità del capitalismo con tutto. Nel 2011 una strana epidemia che nasce da un fungo in Cina si diffonde in tutto il mondo (dalla Cina, ossia la patria del nuovo vecchio capitalismo) e scatena una febbre che trasforma gli esseri umani affetti in creature simil-zombesche che si comportano come automi e ripetono le azioni e i gesti che erano soliti fare, all’infinito fino alla morte (cosa questa che ricorda un po’ gli “stragglers” di Zone One). Non necessariamente azioni che la società capitalista ti obbligava a fare in quanto produttore: guidare un taxi, correggere le bozze di un libro, apparecchiare in tavola, ma anche azioni comuni, innocui e improduttive, gesti che facciamo in quanto consumatori inebriati dalle gioie dell’intrattenimento, come provarsi dei vestiti. Una febbre asiatica, quindi, che trasforma tutti in gregge, alveari, ma che in realtà sembra mostrare come siamo ormai tutti già degli automi programmati dalla logica del pane et circensem su cui si poggia in gran parte la società contemporanea che tende a addomesticare in consumatori i suoi cittadini liberi.
A raccontare tutto è la protagonista Candace Chen, giovane ragazza cinese trapiantata negli Stati Uniti che si trova a lavorare per una multinazionale dell’editoria. Candace racconta il ricordo degli ultimi mesi prima dell’epidemia mentre sta vivendo i primi mesi della fine del mondo come lo conoscevamo e racconta di come è entrata in contatto con un gruppo di sopravvissuti, otto persone in tutto, che sotto la guida para-militaresca di Bob. Finiscono per stabilirsi in un ex centro commerciale, insieme del cuore del liberismo e culla del tempo libero: l’epidemia e la fine del mondo come lo conoscevamo sottolinea il problema del mondo prima del collasso: “il problema della condizione moderna era la scarsità di tempo libero. E alla fine c’è voluta una forza della natura per interrompere le nostre routines.”
Ling Ma è brava a ricostruire un mondo, quello del 2011, che soli 7 anni dopo già quasi non esiste più. La New York che descrive è una New York già cambiata e molti di quei luoghi già nel 2018 non esistevano più. Il che dà un senso di catastrofe in corso: il mondo ci sta già in qualche modo cambiando sotto gli occhi. La semantica è sempre stata dinamica: le parole restano sempre uguali, le cose di cui quelle parole sono nomi però cambiano, ma mai così in fretta come in questi tempi. New York si chiama sempre New York, ma già quella del 2011 è una città morta e diversa da quella viva sette anni dopo.
C’è un collasso totale, delle strutture economiche, delle infrastrutture logistiche, delle gerarchie sociali. C’è il bisogno di ricostruire ciò che si è perso, ma senza una figura forte di Leviatano, e senza una teorizzazione forte di un contratto sociale, su Severance non c’è “il continuo timore e pericolo di una morte violenta” in un mondo dove “la vita dell’uomo è solitaria, misera, ostile, animalesca e breve” (Hobbes, Leviatano), non c’è uno stato di natura ingenuamente ottimista di uomini “industriosi e razionali” privi de “la bramosia degli uomini rissosi e litigiosi” (Locke, Secondo trattato sul governo).
Il punto di forza di Severance risiede proprio nel suo essere un romanzo di genere anti-genere. Ci si aspetterebbe da un momento all’altro un Leviatano che crea quel tanto di violenza che basta per rendere intrattenimento una storia, e invece tutto procede sottovento. Viene descritto l’inizio della fine, il modo in cui chi resta cercherà di capire cosa stia accadendo, si giustappongono e per certi versi si contrappongono un presente obliterato e un passato prossimo già diventato quasi preistoria e si mostra la contingenza di collassi ciclici, come il movimento Occupy!, che nel 2011 documentava una catastrofe economica che poteva anche peggiorare. Su Severance il movimento Occupy! diventa il chiaroscuro di una serie di collassi ben più profondi che si sovrappongono a quello economico: il nostro mondo è solo una costruzione, una finzione contingente e accidentale. La crisi economica non è niente in confronto all’epidemia di Severance, e l’epidemia di Severance è meno metaforica di quanto si possa pensare. Verrà la vera catastrofe, e avrà altri occhi.
Leggi anche questo articolo di Paolo Latini.
