di barbe, di chiome d’alberi e di folte ciocche
«Aveva sognato che sua moglie lo tradiva. Gilbert Silvester si svegliò ed era fuori di sé. I capelli neri di Mathilda si spandevano sul cuscino accanto a lui, tentacoli di una maligna medusa intinta nella pece. Folte ciocche si muovevano adagio con i suoi respiri, strisciavano verso lui».
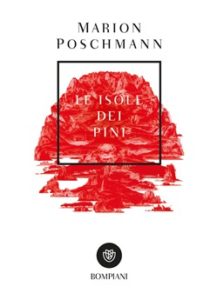 Inizia così il romanzo di Marian Poschmann, Le isole dei pini, pubblicato da Bompiani un mese fa, con la traduzione di Dario Borso: a ricordarci che all’inizio di tutto ci sono sempre un uomo, una donna e un sogno a dividerli. Un po’ come accade ne Il libro nero di Orhan Pamuk, dove però Galip contempla Rüya dormire «nel buio dolce e tiepido, sotto i rilievi, le valli ombrose e le delicate colline celesti dell’azzurra trapunta a quadri che copre il letto», ed è geloso degli eventi meravigliosi che hanno luogo dentro di lei. Geloso degli altri uomini che forse lei sta sognando.
Inizia così il romanzo di Marian Poschmann, Le isole dei pini, pubblicato da Bompiani un mese fa, con la traduzione di Dario Borso: a ricordarci che all’inizio di tutto ci sono sempre un uomo, una donna e un sogno a dividerli. Un po’ come accade ne Il libro nero di Orhan Pamuk, dove però Galip contempla Rüya dormire «nel buio dolce e tiepido, sotto i rilievi, le valli ombrose e le delicate colline celesti dell’azzurra trapunta a quadri che copre il letto», ed è geloso degli eventi meravigliosi che hanno luogo dentro di lei. Geloso degli altri uomini che forse lei sta sognando.
Qui invece il sogno accade nella testa di Gilbert Silvester. Appartiene a lui e a lui soltanto, eppure ecco che, come una minaccia, il sogno proietta la sua ombra sul cuscino e a Gilbert pare che i capelli neri di Mathilda si muovano strisciando verso di lui. Come se quelle “folte ciocche” fossero serpenti. Serpenti di “una maligna medusa” che, se Gilbert non fosse lesto ad alzarsi, forse finirebbero per stritolarlo. Ma, appunto, Silvester si alza e per questa volta è salvo. Si alza dal letto ed esce di casa. Quando la sera rientra, il sogno non si è però dileguato e neanche sbiadito, e così egli litiga con la moglie, afferra due o tre cose, esce di nuovo, attraversa la città, scende nella metropolitana e giunge in aeroporto dove trascorre la notte al Terminal B, per poi il mattino seguente imbarcarsi sul primo volo intercontinentale prenotabile all’ultimo momento e diretto a Tokyo.
Perché sì, Gilbert Silvester se ne va a Tokyo senza dire nulla a Mathilda. Per ripicca. Perché lei lo ha tradito, anche se soltanto in sogno. Se ne va a Tokyo per motivi di studio, perché anche se non lo aveva premeditato, quando si è ritrovato all’aeroporto e sul tabellone ha letto Tokyo, gli è tornato in mente di essere un esperto di barbe. Non un esperto qualsiasi, ma un vero e proprio studioso. Perché Gilbert è ricercatore all’interno di un progetto universitario sulle tipologie di barba. Un progetto sponsorizzato dall’industria cinematografica della Renania settentrionale-Vestfalia, nonché, in percentuali minori, da un’organizzazione femminista di Düsseldorf e dalla comunità ebraica della città di Colonia. Il progetto indaga l’importanza delle rappresentazioni della barba nel cinema, dove entrano in gioco fattori quali i cultural studies, la teoria del gender, l’iconografia religiosa e questioni filosofiche sui rapporti tra espressione e immagine.
“Stili di barba e immagine di Dio” è il titolo della sua ricerca che, secondo l’umore del giorno, egli percepisce come fertile ed elettrizzante o come assurda e profondamente demoralizzante.
Il fatto è che sul tema della barba nipponica circolano svariate teorie. Nessuna che però tenga conto del rapporto tra tipo di barba e immagine di Dio. Una lacuna, secondo il punto di vista di Gilbert, una lacuna che lui ha intenzione di colmare. Almeno nelle intenzioni iniziali. Perché il viaggio che Gilbert sta per compiere va oltre ogni aspettativa: sua, e di noi lettori che lo abbiamo seguito fin qui, fino a questo aeroporto di una città tedesca, mosso da un sogno che lo ha indotto a lasciarsi ogni cosa alle spalle.
Dobbiamo però stare attenti nel non svelare troppo la trama, perché questo non è soltanto un pezzo sonnambulo ma anche una recensione: è una recensione sonnambula. Una recensione sonnambula su un romanzo composto come fosse la mappa di un depistaggio, perché tutto quello che accadrà a Gilbert Silvester una volta giunto in Giappone è misterioso ed enigmatico.
Se rileggiamo l’incipit, troviamo un’indicazione importante: «Gilbert Silvester si svegliò ed era fuori di sé». Fuori dal suo corpo, forse. Come se il suo viaggio verso un aldilà fosse già cominciato.
Non è un caso, allora, che la prima persona che egli incontri a Tokyo sia un ragazzo, Yosa Tamagotchi, aspirante suicida, munito di una barba caprina («Dio aveva una barba folta, Satana una barba caprina») e di un libro intitolato The Complete Manual of Suicide, una guida dei luoghi più mistici del Giappone nei quali uccidersi. Gilbert salva Yosa e lo porta con sé, cercando di convincerlo a compiere un altro itinerario che intanto il nostro protagonista ha ricavato acquistando alcune opere di Saigyú Húshi (1118-1190) e di Matsuo Bashú (1664-1694), due grandi poeti haiku della tradizione giapponese. Due mistici che a un certo punto della loro vita avevano abbandonato la loro casa e i loro affetti e si erano messi in viaggio. Proprio come Gilbert Silvester, che si mette sulle tracce di Bashú per raggiungere Matsushima: «il posto più bello del Giappone, la baia delle Isole dei Pini. A Gilbert l’idea piacque moltissimo. La sua situazione personale era in fondo simile, si era lasciato tutto alle spalle, aveva compiuto una svolta improvvisa, si era allontanato per quanto possibile dalla sua esistenza mondana. Come Saigyú, aveva lasciato sua moglie all’oscuro dei suoi piani. Quelli che andavano in viaggio a Matsushima erano spiriti bizzarri, sognatori, eccentrici. Scrivevano le proprie biografie spirituali, nulla contava per loro se non la poesia, e la poesia significava per loro la via della mente verso il nulla. Erano estremisti, asceti, pazzi per un certo tipo di bellezza: la bellezza fugace dei fiori, la bellezza ambigua del chiaro di luna, la bellezza vaga di un paesaggio appartato. Gilbert immaginò la luna piena sopra i pini neri. Una luna argentea, profusa su silhouette irsute, le ispide fisionomie di vecchi girovaghi. Monaci vaganti. Artisti con barbe lunghe fino alle ginocchia. Sogghignò eccitato nelle profondità della sua stanza, nelle profondità dell’universo, e si sistemò sul cuscino troppo molle. Aveva uno scopo».
due grandi poeti haiku della tradizione giapponese. Due mistici che a un certo punto della loro vita avevano abbandonato la loro casa e i loro affetti e si erano messi in viaggio. Proprio come Gilbert Silvester, che si mette sulle tracce di Bashú per raggiungere Matsushima: «il posto più bello del Giappone, la baia delle Isole dei Pini. A Gilbert l’idea piacque moltissimo. La sua situazione personale era in fondo simile, si era lasciato tutto alle spalle, aveva compiuto una svolta improvvisa, si era allontanato per quanto possibile dalla sua esistenza mondana. Come Saigyú, aveva lasciato sua moglie all’oscuro dei suoi piani. Quelli che andavano in viaggio a Matsushima erano spiriti bizzarri, sognatori, eccentrici. Scrivevano le proprie biografie spirituali, nulla contava per loro se non la poesia, e la poesia significava per loro la via della mente verso il nulla. Erano estremisti, asceti, pazzi per un certo tipo di bellezza: la bellezza fugace dei fiori, la bellezza ambigua del chiaro di luna, la bellezza vaga di un paesaggio appartato. Gilbert immaginò la luna piena sopra i pini neri. Una luna argentea, profusa su silhouette irsute, le ispide fisionomie di vecchi girovaghi. Monaci vaganti. Artisti con barbe lunghe fino alle ginocchia. Sogghignò eccitato nelle profondità della sua stanza, nelle profondità dell’universo, e si sistemò sul cuscino troppo molle. Aveva uno scopo».
E ancora: «Le Isole dei Pini di Matsushima sono uno dei tre paesaggi più belli del Giappone. Il loro aspetto è considerato classico, ispirante e poetico. Per questo sono un luogo predestinato alla poesia, un cosiddetto guanciale poetico. Per secoli i poeti giapponesi hanno pellegrinato in luoghi di particolare fascino paesaggistico, in luoghi ricercati, degni di ammirazione, i quali sono così invitanti e piacevoli che volentieri lì si posano le poesie. Anch’io volevo andare in un luogo che così tanti avevano visitato durante i loro viaggi. Matsushima, viene detto, è un guanciale particolarmente gonfio. Si tratta di innumerevoli isole, a volte minuscole, su cui crescono nodosi pini neri. I pini principeschi dei giardini imperiali vengono potati secondo il loro modello: devono sembrare piegati dal vento, selvaggi, come se la loro forma fosse attribuibile non a mano umana bensì alle intemperie. Vecchi pini, simbolo della perseveranza, della serietà e del rigore che forse verranno concessi al saggio alla fine della sua vita. Il pino nero giapponese prospera solo nell’impero delle isole nipponiche e in parti della Corea. Tentativi di piantarlo sulla costa orientale nordamericana non ebbero successo, gli alberi furono subito colpiti da malattie e parassiti e morirono. Eppure questo pino è un albero costiero, regge senza problemi spruzzi d’acqua salata, resiste ai venti salmastri. Il suo legno viene impiegato volentieri per i palchi del teatro Nú poiché non scricchiola, del resto la scena Nú è spesso addobbata o dipinta con pini. Infatti il pino è ritenuto il luogo della manifestazione divina. È il punto nel mondo dove gli dei scendono come un fulmine, così si dice, che passa per una conduttura. Il pino silvestre europeo spartisce molte caratteristiche con il pino nero. È il mezzo di sostentamento della mamestra, della cucullia, della lymantia monaca e della processionaria dei pini, tignole dai risvolti sacri, ed è anche la sede di quel silenzio spettrale degli avi che collega tutte le specie pinifere della terra.
La strada per raggiungere Matsushima, nel nord del Giappone, è però irta di difficoltà, e i due itinerari – quello di Gilbert e quello del giovane Yoso – si sovrappongono. Yoso vorrebbe andare sul vulcano Mihara dal cui cratere, nel corso dei secoli, in molti si sono gettati, mentre Gilbert aspira a raggiungere le Isole dei Pini. Suicidio esteriore, suicidio interiore. Annullare il proprio corpo, annullare il proprio ego. Gilbert e Yoso, così apparentemente diversi, sono invece forse l’incarnazione di un’unica grande identità. Uguale è la luce che cade su di loro. Una luce soffusa che proietta sulla terra i loro passi come fossero ombre di passi già fatti da generazioni di uomini venuti prima di loro in un mondo che però oggi non c’è più. Perché «i luoghi di Bashú nell’area metropolitana di Tokyo, non valgono più niente. Non meritano una visita, il tempo moderno vi è passato sopra e ha distrutto la loro grazia».
 Le isole dei Pini è un romanzo sorprendente, caustico, sferzante. Da leggere all’imbrunire o al mattino presto, prima o dopo un sogno, per continuarne la visione e l’incantamento, al punto da non distinguere più se ci siamo appena addormentati o svegliati, con un occhio aperto e l’altro chiuso, non del tutto coscienti. Un romanzo in cui tutto si confonde e si intreccia: come se le barbe e le chiome degli alberi fossero associazioni libere, simboli, mascheramenti di quelle “folte ciocche” di Mathilda sparse sul cuscino e che devono essersi intrufolate nei “Giardini della memoria” di Gilbert. Quegli stessi Giardini del Sogno di cui parla Celâl Salik ne Il libro nero di Pamuk.
Le isole dei Pini è un romanzo sorprendente, caustico, sferzante. Da leggere all’imbrunire o al mattino presto, prima o dopo un sogno, per continuarne la visione e l’incantamento, al punto da non distinguere più se ci siamo appena addormentati o svegliati, con un occhio aperto e l’altro chiuso, non del tutto coscienti. Un romanzo in cui tutto si confonde e si intreccia: come se le barbe e le chiome degli alberi fossero associazioni libere, simboli, mascheramenti di quelle “folte ciocche” di Mathilda sparse sul cuscino e che devono essersi intrufolate nei “Giardini della memoria” di Gilbert. Quegli stessi Giardini del Sogno di cui parla Celâl Salik ne Il libro nero di Pamuk.
«Gilbert sognò di stare seduto in treno, un’altra volta, di nuovo, per sempre. Fiancheggiarono il Fuji per ore, senza che il monte si avvicinasse, senza che il paesaggio mutasse. Andavano veloci, udì anzi il rumore di un treno sfrecciante, ma al contempo erano fermi stabilmente nello stesso posto, accerchiati da un grigio impenetrabile che premeva contro i finestrini».
Gianluca Minotti
