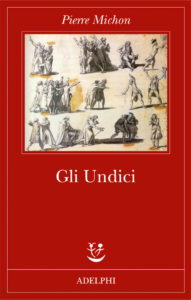 di Giuseppe Giglio
di Giuseppe Giglio
Si scopre subito dal risvolto di copertina, prima di cominciare la lettura: François-Élie Corentin, un talentuoso pittore – da giovane bello e insolente, con «la sua gaiezza cupa, i suoi modi ora arroganti, ora obliqui, torvi» – che era stato allievo del Tiepolo, non esiste. Come non esiste il suo capolavoro, commissionatogli nel mese di nevoso (gennaio 1794) del calendario rivoluzionario francese: Gli Undici, un olio su tela in cui sono ritratti i membri – undici, appunto – di quel Comitato di Salute Pubblica che aveva decapitato il tiranno, il re, e che deteneva un potere assoluto e fantasma nella Francia del Grande Terrore. Eppure appare tutto così reale, così vivo, in questa nuova e paradigmatica storia di Pierre Michon (uscita in Francia nel 2009, dopo una lunga gestazione, ed ora edita da Adelphi, con lo stesso titolo del dipinto, 134 p., 16 €): la vita di Corentin e questo quadro (quello della imperitura fama) che fino alla fine sembra troneggiare, sotto uno spesso vetro blindato, in una grande sala del Pavillon de Flore del Louvre. Un racconto lungo, più che un romanzo, snodato su una scrittura magmatica, coltissima, fortemente allusiva: una lingua sontuosa, densa di echi pittorici e letterari, che – in un’atmosfera sordida e caravaggesca – illumina per metafore e dal basso la narrazione; una lingua superbamente restituita (riscritta) nella traduzione di Giuseppe Girimonti Greco.
E così, attraverso le vicende di Corentin (a partire dall’infanzia a Combleaux, nel Limosino, sotto le ampie sottane delle donne di casa: la madre e la nonna, che lo divoravano d’amore), scorre davanti agli occhi del lettore (incalzato da un istrionico e demistificatore io narrante) il Settecento, il «secolo di ferro della dolcezza del vivere», il secolo dei Lumi. Tra le vie e la gente di quel borgo sulla Loira che si fa emblema di un modo di essere, in un mondo in cui «Dio è cane, e quando si è miseri, non si può crescere che camminando nell’ancor più misero». Il nonno materno del pittore, un ugonotto apostata, vivendovi, a Combleaux, da sfruttatore dei più poveri (sterratori e muratori), mentre si arricchisce facendo costruire canali e dighe; non molto diversamente dal vecchio Corentin, il nonno paterno, che moltiplica il vino come Cagliostro moltiplicava l’oro. Per non dire di suo figlio, il padre di François-Élie, che a Parigi dilapida il patrimonio di famiglia «in rime anacreontiche», lontano dalla moglie, piena dei desideri della giovinezza, e da François-Élie ancora bambino: nell’esercizio, per lui improbabile, delle lettere. E se il letterato Corentin pensa che lo scrittore dev’essere «non un ciambellano della parola, né un addetto ai sollazzi», ma «una potente macchina per aumentare la felicità dell’uomo», dentro un’arcadia di sollazzi e cicisbei (dove egli stesso si perde) prendono invece forma le ipocrisie e le convenienze, le debolezze e i giochi di potere che all’uomo, alla sua natura, da sempre appartengono.
Michon, oramai un classico della letteratura francese contemporanea, torna con questo visionario romanzo che viene dopo Vite minuscole (pubblicato sempre da Adelphi nel 2016, con molto successo). Un esordio folgorante, quel libro: dove una scrittura di abbagliante ricchezza sottrae all’oblio dieci personaggi per niente famosi o esemplari; e dove è già presente la visione michoniana dell’uomo e del mondo: disincantata e ironica, avvezza a scivolare tra le ambiguità e le oscurità dell’animo umano e della Storia, fiduciosa nel potere rivelatore della vera letteratura, del «mestiere dell’uomo». E anche ne Gli Undici Michon, ben sapendo che «ogni uomo è capace di tutto», tiene ben accesa la sua lanterna sulle vite, private e pubbliche, che ha scelto di raccontare. Da quella finestra – il Terrore – da cui le fazioni, i partiti, finiscono per rivelarsi soltanto dei «ruoli» (i ruoli si possono dipingere, precisa la voce narrante), in quel «vecchio teatro d’ombre» che è la politica. Da quel famoso quadro, da quella «bella e lucrosa farsa», da quell’inganno pagato con un altissimo compenso (da eseguirsi nella massima segretezza, con Robespierre ed il suo gruppo al centro e più in evidenza, gli altri dovendo figurare come comparse), che alla fine si svela come un’ultima cena senza Cristo, truccata, «perché gli uomini sono diventati più forti di questa assenza». Un jolly, insomma, quella pittura: da giocare «a seconda della lettura che gli eventi avrebbero richiesto», in quella palude di subdole trappole, lotte intestine e assidue ghigliottine.
Non manca, naturalmente, la Storia, in questa storia di oscurità, di pastrani «color fumo dell’inferno», di fantasmi shakespeariani che abitano alcuni personaggi: come quei tre che in una notte da lupi hanno voluto Gli Undici da un Corentin per nulla sorpreso, che aveva «il sorriso del coccodrillo». Laddove Michon mette in scena persino un Jules Michelet, il grande storico, che qui, ispirato da un altro quadro, uno schizzo di Gericault, che a quello di Corentin lo conduce, dedica addirittura alcune pagine della sua Storia della Rivoluzione francese proprio a Gli Undici. Un Michelet che mezzo secolo dopo i fatti va a visitare la sacrestia di Saint-Nicolas-des-Champs, dove venne ordinata quella grandiosa opera al pittore di Combleaux. Lo segue, il narratore interno, quello storico mutato in personaggio – pallido e fremente, coi capelli precocemente bianchi – che va a vedere, a verificare: lui stesso così vivendo (e facendo vivere) quella notte di inquietanti trame. E intanto va affiorando un dubbio, non meno inquietante, sulla Storia (lo stesso che era stato di Gesualdo Bufalino): se essa – che con Michelet prende il nome di potenze, di terrori, di massacri -, se essa, la Storia, sia un boia dai cento occhi o una sonnambula cieca.
